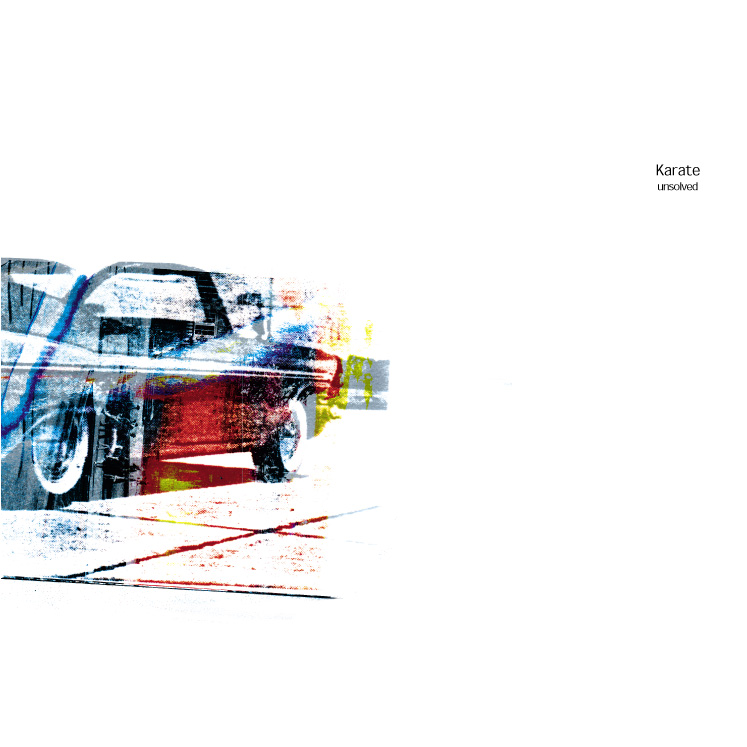Per tempo intendo quello individuale. Insomma: la morte. Quasi sempre un tabù di cui non parlare. Ricordo il funerale di un conoscente (il fratello di un mio carissimo amico) qualche anno fa, morto suicida. Tra l’incrudilità, il dolore, la costernazione generale lo accompagnammo in una funzione scarna, e se non ricordo troppo male, laica, a una sorta di luogo di raccoglimento – mi verrebbe da dire “cappella”, ma il rimando a una funzione religiosa che mi pare non ci fu – in cui stemmo, in silenzio, a fronteggiare la bara che da lì sarebbe partita direttamente verso il forno crematorio.
C’era della musica di sottofondo. Forse un po’ insulsa, di sicuro non scelta da nessuno. Di circostanza.
Colui che scandiva i tempi di questo saluto (chi era? Quello delle pompe funebri? Non ricordo…), interrompendo musica e silenzio degli astanti, chiese se qualcuno volesse dire qualcosa, un’ultima cosa per il defunto. Un ultimo messaggio.
Ma forse alla musica – a una musica scelta – dovrebbe essere affidato un ultimo messaggio, pensavo stasera mentre ascoltavo un vecchio lavoro (2000, 16 anni fa) di un gruppo sconosciuto ai più, statunitense, che fa rock misto a quel curioso genere definito “indie”, che nella mia personale – e forse un po’ grezza, credo – tassonomia non ho mai capito bene cosa volesse dire.
Me li fece scoprire un amico (eccola lì la potenza della musica!) che andai a trovare nell’agosto del 2007 a Berlino. Una pazza corsa agostana, dalla Toscana del nord fino a lì, con le soste minime per cercare di non essere raggiunto da quel me stesso da cui volevo fuggire, gli ultimi 400 km a oltre 200 all’ora di media, in scia a un’indigeno che guidava benissimo su autobahn a 4, a tratti a 5 corsie. Sogno di libertà solipsistica, individuale e fuga, appunto. Frutto di ingannevole pubblicità a cui si viene sottoposti fin dalle più tenere età, per intere generazioni, le nostre, quelle che mi hanno preceduto e quelle che mi stanno seguendo.
Atti finali di una prima vita che da lì a poco si sarebbe conclusa. E riascoltando in un attimo di pausa, sdraiato al buio sul letto, ripensavo a quel frangente così strano della mia vita, in cui sono stato così in balìa di altri, dei miei sentimenti, del mondo, di avversità che non ho saputo fronteggiare e che portarono a una catastrofe. Eppure loro sono ancora lì, rivitalizzati grazie a Spotify (quando si dice la tecnologia!), che suonano per me ogni volta che voglio, in cambio di qualche bit di connessione ceduto alla compagnia telefonica – ma acquistato con largo anticipo e sempre abbondante – connessione permettendo.
Allora forse mi piacerebbe, in un testamento ideale mai stilato (chi lo ha fatto?), una cerimonia dello stesso tenore: scarna, laica, con gli astanti che ascoltino un paio di cose e pensino che quella è la musica che ho scelto per l’ultimo saluto:
- Protest, in Philip Glass “Songs from the trilogy”
- Evening Song, in Philip Glass “Songs from the trilogy” (queste due in questa sequenza e di seguito)
- This day next year, in Karate “Unsolved” (anche solo la lunga parte finale di chitarra e batteria).
Volevo metterci anche qualche pezzo dei brandeburghesi di Bach, ma viene una cosa troppo lunga. Alla fine si tratta di un saluto. Vorrei che ci lasciassimo così.
Così che i presenti, se lo vogliono, si possano portare a casa – e forse nel cuore – quei pezzi e che quelle note possano essere il messaggio da ascoltare, magari una sera che si è stanchi, che si ha bisogno di staccare una mezz’ora, al buio, sdraiati sul letto o su un divano, con le cuffie o anche senza. Sì, quando accadrà, lasciamoci così. Sarebbe un bel regalo.