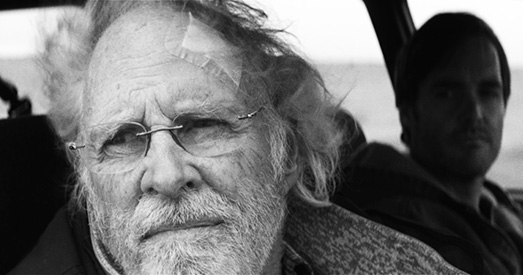Mi è arrivata una richiesta di autorizzazione sulla carta di credito da parte di Omnitel-Vodafone. A parte il fatto che non credevo ancora esistesse la società Omnitel, ma da secoli non ho un’utenza che faccia capo a questo gestore telefonico.
Leggermente sospettoso giro la mail alla banca con una richiesta di spiegazioni che, dopo qualche giorno, arriva. Sostanzialmente mi si dice che devo sentire la società e chiarire con loro. Cerco un indirizzo mail a cui poter scrivere e ovviamente sul sito Vodafone c’è di tutto tranne quel che serve: non un servizio clienti (anche se cliente non sono), né altro. In compenso sul motore di ricerca vengono fuori tutti i “risultati” della gente inviperita contro questo gestore che pare – stando a quel che si trova su web – non brilli esattamente per trasparenza e customer care.
Apprendo però che esiste un Vodafone “lab”, una specie di servizio “sperimentale” e c’è anche una mail alla quale rivolgersi: lo faccio subito e, devo dire, con inattesa sollecitudine, ricevo risposta quasi immediata stamattina, nonostante sia sabato. Risposta che però mi lascia alquanto perplesso e che, non essendoci nulla di segreto, cito qui di seguito:
Buongiorno.
Per questo tipo di informazioni la invitiamo a contattare il Servizio Clienti Facebook compilando il seguente form: http://on.fb.me/ServizioClienti
In alternativa, se le serve assistenza personalizzata su prodotti e servizi Vodafone, può fare la sua richiesta sul canale Twitter di Vodafone: i nostri operatori le risponderanno alla velocità di un tweet. http://www.twitter.com/vodafoneit#tw190Cordiali saluti.
Vodafone Lab Staff
Ovvero: una delle società di telefonia mobile più grande d’Europa, una multinazionale, ha il suo servizio clienti su Facebook! Ho pensato: è uno scherzo o, perggio, phishing: cliccherò su questi link e il computer esploderà. Invece pare sia tutto vero: lo short link rimanda a Facebook, ma… guardate cosa mi chiedono prima di poter fruire del servizio:

Vale a dire: vuoi fruire del nostro servizio clienti? Cosa ci dai in cambio? Tutti i cavoli tuoi su facebook, la lista dei TUOI amici oltre ovviamente al tuo indirizzo mail… Insomma non mi pare un prezzo “basso” per fare una domanda! Chiaro che ho cliccato su “annulla”: la prossima volta che vado in centro, passo da un centro Vodafone e cerco di risolvere da lì…
Ce la possiamo fare? No, non ce la possiamo fare…