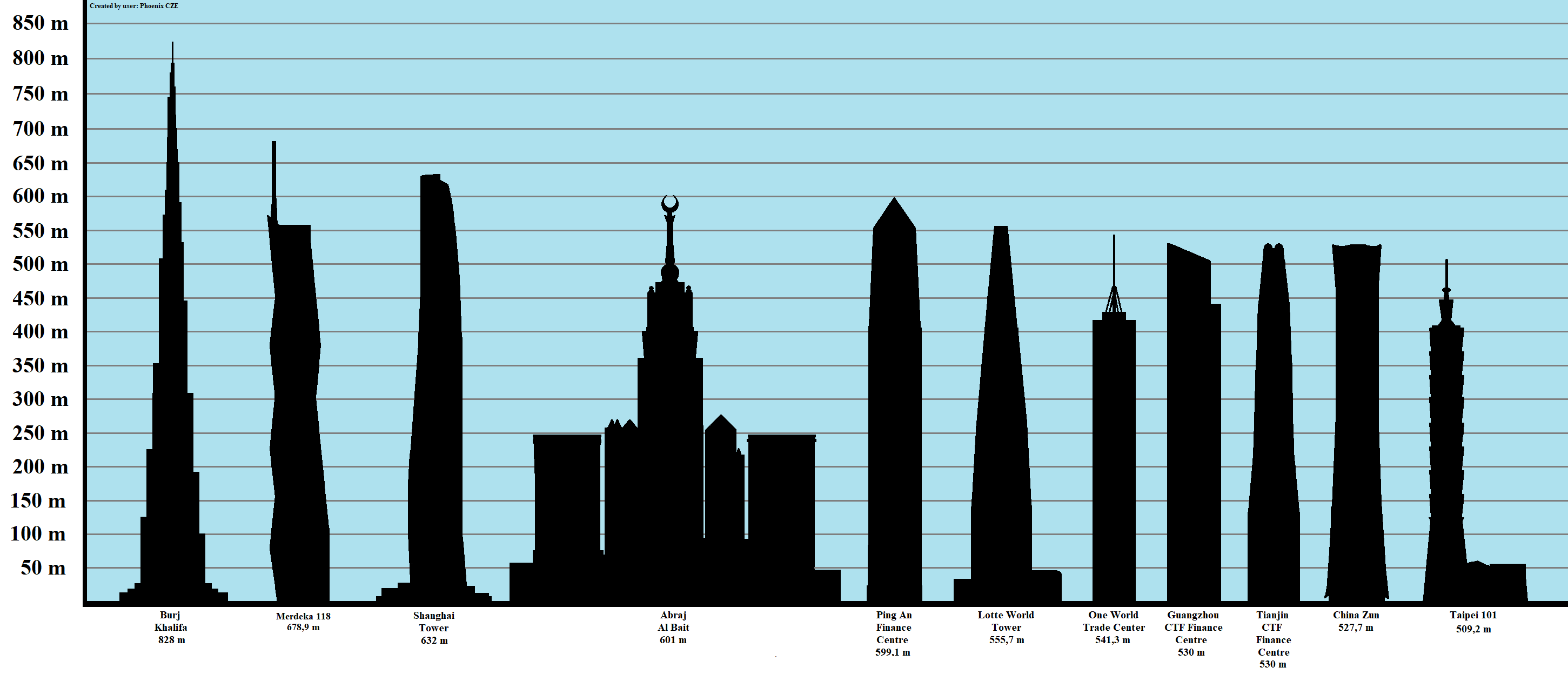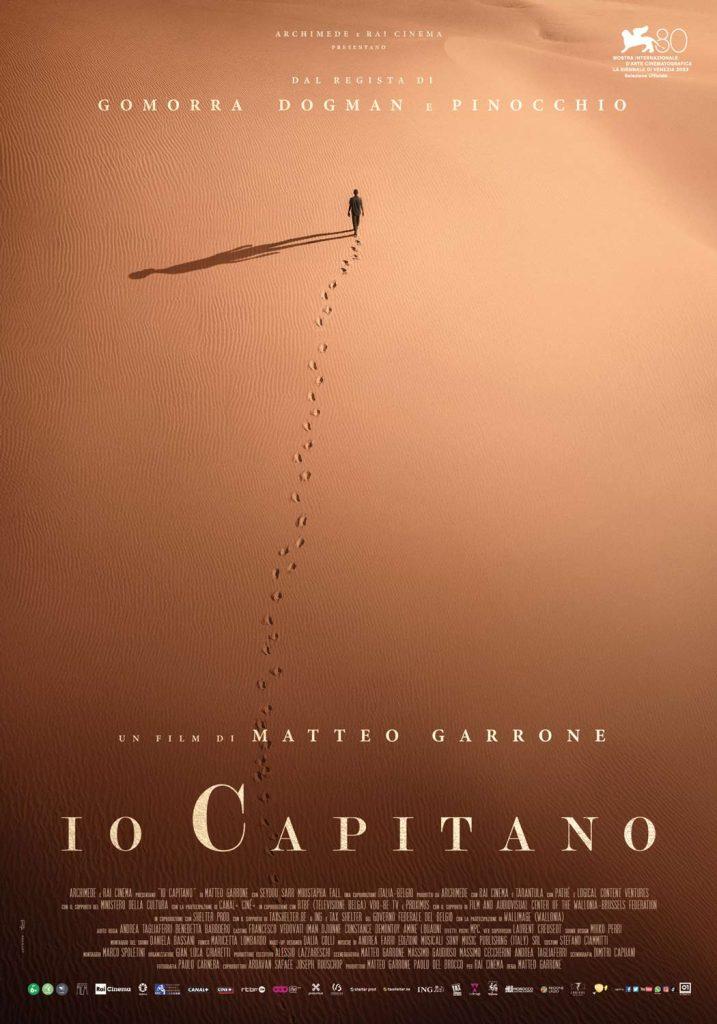C’è una strana maledizione che accompagna gli scrittori (in viaggio ma non solo) — una maledizione lieve o tremenda, a seconda dei casi, ma sempre significativa: quella della perdita.
Non del bagaglio o del denaro, ma della scrittura stessa: degli appunti, del dattiloscritto, del taccuino dove il mondo si stava già trasformando in racconto.
Nicolas Bouvier la conosce bene. In La polvere del mondo, dopo mesi di fatiche e di polvere vera, racconta l’episodio quasi di passaggio, ma con il tono dolente di chi ha visto dissolversi una parte di sé: il suo dattiloscritto — il cuore del viaggio — finito tra le mani distratte di un inserviente, sparito per sempre. È una scena che suona come un ammonimento: il mondo restituisce al viaggiatore tutto ciò che vuole, tranne la possibilità di fissarlo davvero. Scrivere, per Bouvier, è un modo di viaggiare ancora; perderne la traccia è quasi un ritorno all’essenza del cammino, dove nulla resta.
A distanza di decenni, un episodio simile accade a Marco Paolini (che si cela fino a metà libro con lo pseudonimo di “740”, storica locomotiva delle ferrovie italiane): in viaggio con Paolo Rumiz, in “seconda classe“, gli rubano lo zaino. Dentro c’erano anche gli appunti, i pensieri nati dal tragitto — quella minuta sedimentazione di sguardi e parole che fa di ogni tappa una piccola storia. Ma anche qui la perdita diventa parte del racconto: ciò che scompare obbliga a reinventare, a riattraversare il percorso con la memoria, a fidarsi di un’altra forma di scrittura, più orale, più fragile e forse più vera.

La copertina del libro
Ma la “maledizione” può assumere toni ben più crudeli. Nel 1913, Dino Campana affida a Soffici e Papini il manoscritto del suo Il più lungo giorno. Chiede solo di leggerlo, di aiutarlo a pubblicarlo. Lo perdono — o peggio, lo dimenticano. Campana, furioso e disperato, lo riscrive a memoria: nasce così Canti Orfici, un libro che vibra di follia e di genio, ma anche del trauma della riscrittura, della ferita che diventa forma. Quasi sessant’anni dopo, il manoscritto originale riaffiora fra le carte di Soffici, come un fantasma tardivo, inutile e beffardo. In Campana, la perdita si fa creazione: non è più l’incidente del destino, ma il motore segreto della poesia.
Anche Hemingway, nel 1922, conobbe il medesimo colpo. Una valigia contenente tutti i suoi manoscritti giovanili sparì a Parigi. Non si riprese mai del tutto, ma da quella frattura nacque una nuova voce, asciutta, essenziale: “bisogna ricominciare sempre da capo”, scriverà più tardi, come se la distruzione fosse una forma di purificazione letteraria.
E poi ci sono i viaggiatori cronici, come Bruce Chatwin, che vivevano nella perdita come in una seconda natura. I suoi taccuini Moleskine — strumenti e simboli insieme — erano un modo di trattenere l’effimero, ma anche di accettare che tutto, prima o poi, svanisce. Per lui, come per Bouvier, il viaggio è già scrittura che si disfa, impronta sulla sabbia, traccia che il vento cancella.
Da Campana a Bouvier, da Hemingway a Paolini, da Chatwin a chissà quanti altri, si delinea una genealogia del perduto: scrittori per i quali il vuoto non è un accidente, ma una condizione. Il manoscritto smarrito, l’appunto sottratto, la pagina bruciata sono figure di una verità più profonda: ogni scrittura nasce da un atto di perdita. Si scrive per salvare, ma anche per constatare che nulla si salva davvero.
Forse è questo, in fondo, il segreto comune di chi viaggia e di chi scrive: camminare sapendo che il mondo, e ciò che si scrive di esso, non ci appartiene.
E che la bellezza — come la polvere del mondo — resta solo a chi accetta di perderla.