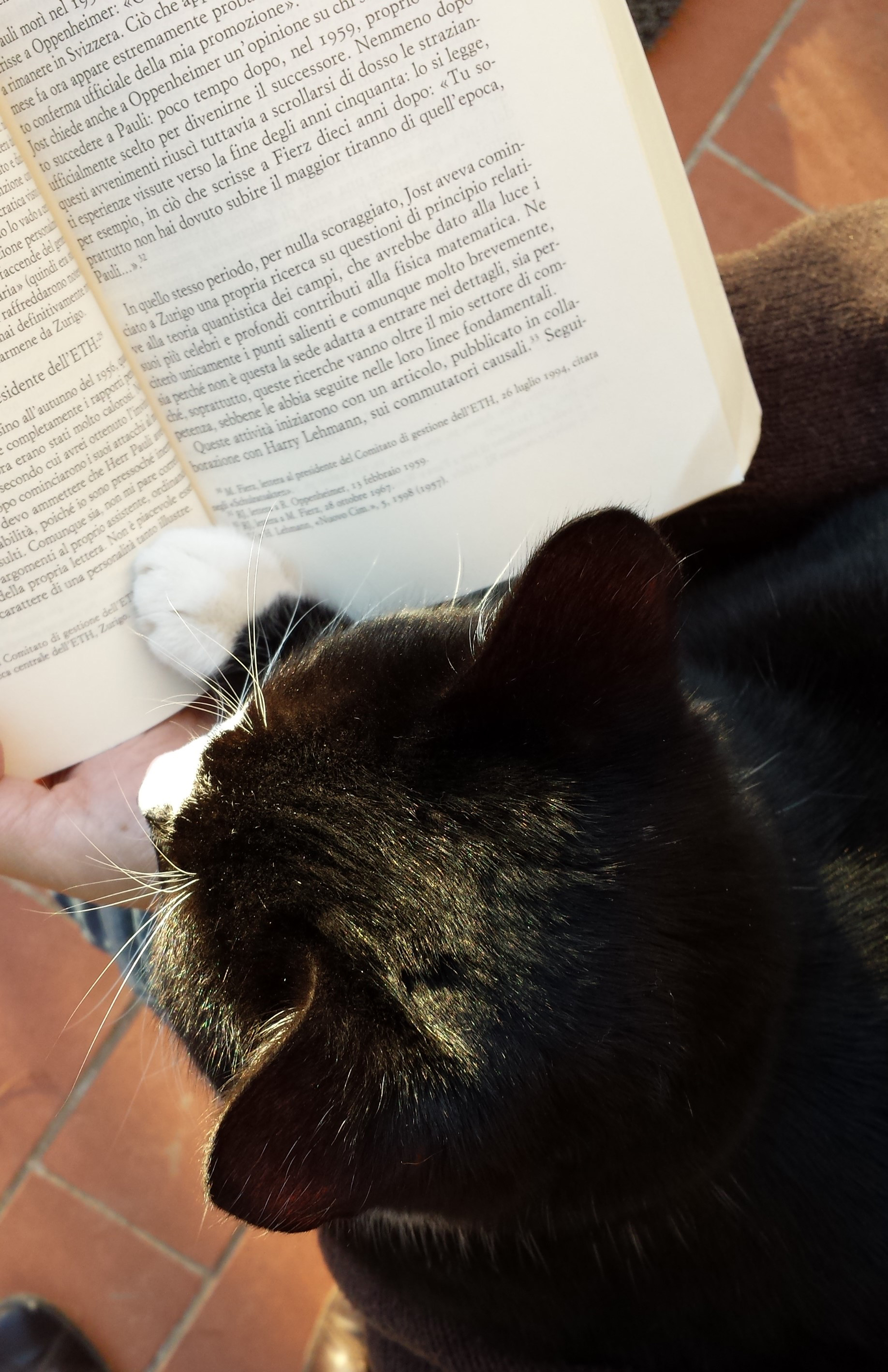Non ho molto da dire sulla questione ambientale. Salvo che è da quando sono ragazzino che ne sento parlare e, ancor oggi, essere preoccupati per del ghiaccio che si scioglie a non so quanti mila chilometri da noi, sembra una preoccupazione da teenager troppo sensibile e nella fase in cui vorrebbe salvare il mondo.
Il problema però è che da quando ero ragazzino, le cose sono cambiate di molto e in peggio, come testimoniano i due documentari segnalatimi dal collega Luca Pardi, che cita un post di Ugo Bardi (questo: http://ugobardi.blogspot.it/2013/12/ghiaccio-e-metano-la-combinazione.html).
Non ho molto altro da aggiungere se non: guardate i documentari (soprattutto il primo che è molto ben realizzato, ma anche il secondo esprime concetti non banali sulla questione) e cercate di fare quel potete/volete se siete sensibili al tema. Io, per esempio, per il prossimo Natale, mi sono regalato un paio di cose (un libro e un DVD) di James Balog, fotografo e fondatore del progetto EIS (Extreme Ice Survey) e, nel mio piccolo, ho fatto una donazione per il progetto.
Ah: una risata vi seppellirà perché il metano deve essere una specie di gas esilarante, visto che, nel secondo documentario segnalato nella pagina di Bardi (La spirale mortale dell’Artico e la bomba ad orologeria del metano), al minuto 17:50 (e per quasi un minuto) vengono mostrate immagini di un ghiacciaio che si disgrega e curiosamente si sentono delle persone ridere. Una cosa che mi lascia perplesso e allibito. Come ridere a un funerale. Che non dico potrebbe essere quello dell’umanità intera, ma quasi. Bah, valli a capire questi umani!
Il gatto di Schrödinger…
Qualità della vita
Ieri mattina ho preso un aperitivo a Vicopisano, ridente località della provincia pisana, sulla via di Firenze. Zone di campagna, tranquille, che riportano a un passato mitico di quando la nonna ricordava che, una volta, lasciava la chiave sulla toppa di casa, senza il timore che nessuno entrasse. Forse non siamo più a quel livello, ma riempie di gioia star seduto sorseggiando un crodino, al sole e aprire gli occhi per vedere di fronte a sé uno scooter parcheggiato, con casco appoggiato sullo specchietto e chiavi inserite sul cruscotto… Un altro mondo (che speriamo si conservi ancora…).
Buddha seriale
Siamo stati ieri a Maison du Monde, una specie di “anti-Ikea” con prodotti (serialmente) esotici e devo dire spesso un po’ troppo leziosi per i miei gusti (i francesi hanno un gusto che non incontra il mio favore). Gita necessaria per qualcosa da regalare a Natale. In mezzo a tutto questo trovo dei Buddha. Fatti così:

Ora, di religioni orientali so poco per non dire nulla, ma per quel poco che so, la figura del Buddha trova la sua peculiarità proprio nel suo essere multiforme (esiste un Buddha della felicità, uno della speranza, uno della pace, uno della sapienza ecc.). Invece… la rappresentazione ad uso consumistico che ne abbiamo è di una sola specie, direi in posizione classica, come nella tradizioni cristiana lo è il crocifisso. E’ lo spirito del tempo, baby, e tu non ci puoi fare nulla…
Non ce la possiamo fare
Segnalo velocemente – ancora oggi – due episodi scissi tra loro, ma significativi per quel che riguarda l’idea se (/che) ce la si possa fare o meno.
Il primo (micro): alla mensa del posto di lavoro – cronicamente in crisi per essere sottodimensionata rispetto al numero di utenti – si usano spesso piatti e posate di plastica. La lavastoviglie industriale non ce la fa a tenere il passo, non ci sono soldi, da tempo si parla di una ristrutturazione radicale dell’impianto, ecc. ecc. Tutto nella “norma” (?!?). Una norma che prevede una volta al giorno, per una media di mille millecinquecento persone tutti i giorni lavorativi della settimana, l’uso di posate e piatti di plastica. Ma tant’è. Oggi ho preso il passato di verdura, e ho avuto anche la fortuna di prendere un piatto vero e delle posate degne di questo nome. La bustina (per fortuna di carta) che le contiene non prevede però il cucchiaio che di solito, quando ci sono passato di verdura o altri “piatti liquidi”, viene messo a parte, in un cestellino. Oggi il cestellino semplicemente non c’era. Ho chiesto alla signora della mensa che con la massima serenità mi ha detto di prendere quello nella confezione/bustina (di plastica) delle posate di plastica (sempre disponibili). La bustina che io prendo per prendere dei tre oggetti SOLO il cucchiaio, devo aprirla, vanificando le condizioni igieniche e lasciando che tutto sostanzialmente venga buttato via. Non ce la possiamo fare.
Il secondo (macro) merita un titolo: «No alla ‘ndrangheta, sì a Versace». Leggere a questo link per credere (e se «Repubblica» dovesse archiviare la notizia altrove, la trovate comunque a questo link in PDF). Senza parole e, ancora una volta, non ce la possiamo fare.
Le corbellerie di Corbellini
Ho appena finito di leggere il “sampietrino” (collana così nominata dall’editore Bollati Boringhieri… credo intenzionalmente) dal titolo «Scienza», di Gilberto Corbellini. Agile volumetto di circa 150 paginette, molto interessanti e condivisibili – almeno personalmente – per gran parte delle cose che vengono dette, mi trova però in forte disaccordo per almeno un paio di punti che mi appaiono nebulosi e contraddittori. In particolare dove si affronta l’argomento OGM (ripreso per altro sempre per accenni polemicamente più volte), alle pagine 72-73:
Allora perché tanto chiasso? Ci sono alcuni professori o ricercatori, neppure presenti nel panorama della ricerca di alto profilo internazionale o nazionale, i quali si prestano ad accreditare pregiudizi ideologici contro la produzione e l’uso di OGM. Sono tre o quattro, naturalmente amplificati dalle chiacchiere terroristiche di una maggioranza di intellettuali e politici che hanno degli interessi economici e traggono vantaggio da una propaganda demagogica contro gli OGM.
L’aspetto sconcertante di questa faccenda è che altrove nel libro l’autore condanna la “confusione” generata dalla mescolanza di dati oggettivi e scientifici e le opinioni (o strumentalizzazioni) che da essi discendono. Insomma, la regola base sarebbe la solita: un conto sono i fatti, altro conto sono le opinioni. Eppure questa semplice regola, lo stesso Corbellini sembra non in grado di applicarla a se stesso per ciò che riguarda gli OGM. Al netto della genericità di certe espressioni (questa «maggioranza di intellettuali e politici» che traggono vantaggio da una «propaganda demagogica contro gli OGM» – chi sono questi “intellettuali terroristi”? E quali i politici che traggono profitto da queste campagne?), a me (ma questa è ancora una volta un’opinione personale) pare che si voglia vedere solo una parte della realtà. Corbellini, così pronto a sputare sentenze contro politici/intellettuali che supponiamo essere italiani, ha visto la puntata di «Report» (disponibile qui) in cui di queste cose si parla? Forse è troppo “di sinistra” – visto che nel libro un paio di distinguo tra “destra” e “sinistra” sono presenti – ma la trasmissione ha il merito di andare a vedere che fine ha fatto la biodiversità in Canada grazie alla Monsanto, con interviste ad agricoltori che di quello campano, mettendo in luce non solo l’aspetto eminentemente scientifico appunto, ma anche quello etico e sociale, che lega gli agricoltori a certe semente geneticamente modificate (che rispondono solo ai prodotti commercializzati dalla nota multinazionale).
Perché un conto è la scienza – e gli OGM comunque, se il principio di precauzione vale come valore normativo che dovrebbe guidare proprio la scienza e la tecnologia, in assenza di regole certe, non è dimostrato che facciano tutto questo gran bene – e altro conto è l’uso che della scienza si fa. Poi: se si vogliono bollare come demagogia i contratti capestro cui gli agricoltori sono costretti, beh, allora siamo alla mistificazione, visto che lui stesso qualche riga dopo scrive (p. 72):
Per esempio, si dice che gli OGM fanno guadagnare le multinazionali, a partire dalla Monsanto, e danneggiano gli agricoltori che non li vogliono usare, o privano i cittadini del diritto di consumare cibi naturali non inquinati da transgeni.
Quel «si dice che» ahimè appartiene proprio a quella mistificazione che lo stesso Corbellini sembra intenzionato a combattere nel suo libretto. Peccato che questa “ideologizzazione” – da cui lui stesso pretende di essere immune cercando di basarsi sui fatti e oggettivarne le circostanze – gli torni indietro come un boomerang, anche nelle pagine successive (diciamo che una decina di paginette rasentano un po’ il delirio, dalla 72 alla 83). A p. 82-83 ancora:
Non è l’etica che può migliorare l’efficienza economica: forse il contrario. […] Ci sono buoni argomenti per ritenere che l’economia di mercato, insieme ad altri fattori come l’istruzione (soprattutto quella scientifica) e i principi liberaldemocratici, abbiano estratto il meglio dal «legno storto» di cui siamo fatti.
Bah, passerò anche per marxista-leninista, ma a me pare che con queste poche e lapidarie parole Corbellini bellamente ignori le crisi economiche (neo)liberiste (o “evoluzioniste” se a lui piace il termine, che sa tanto di “vinca il migliore”, dove il migliore mi pare che qui coincida evolutivamente con il più furbo e con chi riesce a gabbare meglio e più velocemente il prossimo suo…) che hanno costellato lo scorso e l’attuale secolo: dalla crisi del 1929 negli Stati Uniti, per arrivare alla bolla speculativa prima immobiliare e poi “informatica” da noi, fino al periodo di recessione nel quale ancora viviamo. In queste affermazioni c’è dell’incredibile, ma soprattutto mi pare una superficialità di analisi che non mi aspetterei da uno studioso di questo calibro.
Il Club di Roma e la serietà della ricerca: un ps
Una piccola nota ancora sui problemi ambientali e su come anche le tacite scelte fatte dai futurologi intervistati nel documentario di Cerasuolo Ultima chiamata siano in qualche modo controverse. Al minuto 1:08:35 del documentario Bill Behrens, coautore de I limiti dello sviluppo, viene ripreso mentre esce di casa e sale sulla sua auto, una Toyota Prius, nota per essere l’auto ibrida (motore endotermico + motore elettrico) più venduta al mondo.
Con un caro amico, Ivan Maio, docente al Politecnico di Torino, sporadicamente abbiamo discusso delle possibili alternative ai motori endotermici. Di fronte al mio entusiasmo verso l’avventura dell’elettrico e in particolare verso il “tutto elettrico” (e neppure ibrido…) con auto che, pur costose, hanno un’estetica degna di questo nome (e ahimè la Prius con tutto l’impegno, non lo è) come la Tesla, Ivan mi ha sempre molto raffreddato. E in particolare lo ha fatto in maniera definitiva con questo articolo uscito a fine giugno su IEEE Spectrum (ne allego qui anche una versione PDF nel caso il link scomparisse nel tempo).
Questo per dire che, anche chi con le migliori intenzioni compie scelte personali che siano il segno di una la volontà di andare verso direzioni alternative, non è detto che la direzione che ha scelto l’abbia imboccata per il verso giusto…
PS: qui il sunto video, ad usum delphini, dell’ultimo rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sul cambiamento climatico: http://youtu.be/XVw6dm12Eyw. Mentre qui il commento, risalente a un paio di mesi fa, di Luca Pardi: http://malthusday.blogspot.it/2013/10/cosa-manca-nei-rapporti-dellipcc.html. Buone letture e visioni…
PS: un’amica, nel frattempo, mi ha segnalato quest’altro istituto che si occupa del “futuro dell’Umanita”: Future of Humanity Institute, niente meno che promosso dall’Università di Oxford…
Il Club di Roma e la serietà della ricerca
Qualche giorno fa il collega Luca Pardi, attuale presidente dell’Aspo (Sezione Italiana dell’Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio), mi ha prestato Ultima chiamata, un documentario di Enrico Cerasuolo. Il tema è l’ambiente e lo sfruttamento delle risorse che condurrà inevitabilmente alla catastrofe planetaria. Il documentario narra la storia della nascita del Club di Roma attorno alla figura di Aurelio Peccei (uno di quegli italiani che alzano la media) che, imprenditore e manager di successo, preconizzò «the big problem», quello della sopravvivenza dell’uomo sul pianeta.
La svolta, come dice il documentario, avvenne a Berna nel 1970, dove vi fu la prima riunione del Club, tutt’oggi esistente e con sede in Svizzera, a Winterthur. Peccei – che aveva in mente un progetto di ricerca nel quale si studiasse il futuro del pianeta – incontrò lì Jay Wright Forrester fondatore della «dinamica dei sistemi», la scienza che studia l’interazione tra sistemi complessi e che darà poi luogo a quella che – solo una ventina d’anni dopo, sempre al MIT – verrà battezzata «teoria della complessità». Forrester che non ha bisogno di presentazioni (qui il suo profilo wikipedia), nell’intervista che Cerasuolo gli fa, dice:
A quel primo incontro a Berna, essendo nuovo e americano, pensai che la cosa migliore da fare fosse ascoltare e non dire niente. Alle sei di sera dissero che la Fondazione Volkswagen non avrebbe finanziato la ricerca perché non era stata stabilita la metodologia. Quindi improvvisamente c’era un progetto senza metodologia né finanziamenti, il che si avvicinava molto a un’assenza di progetto.
Poi Forrester confida a un suo vicino di posto, durante la riunione, che quello stava per essere il giorno più interessante della sua vita perché loro avevano un problema, lo avevano individuato e definito, e lui aveva la soluzione:
Gli dissi che potevano venire all’MIT per saperne di più ma che sarebbero dovuti venire per due settimane oppure niente, perché sapevo che gli ci sarebbero volute due settimane per capire bene. E accettarono, a mezzanotte, che sarebbero venuti all’MIT tre settimane dopo.
Ecco questo mi fa impressione: sarà che il passato ha sempre un’aura di magia, ma lo scienziato (1) assiste alla riunione, (2) trova il problema che si pone interessante e una sfida intellettuale degna delle sue capacità (a volte anche superiore, ma «nel più ci sta il meno»…) e (3) invita il gruppo che dovrebbe occuparsene ad andare al MIT per 2 settimane come minimo. Se si pensa alla scienza attuale dove i talk per spiegare i risultati di una ricerca – che magari ha impiegato mesi di lavoro – si hanno 10 minuti…
La storia poi in qualche modo la si conosce: quel fortuito e fortunato incontro darà luogo nel 1972 alla pubblicazione de I limiti dello sviluppo, pubblicato in Italia da Mondadori e scaricabile gratuitamente, da pochi mesi, nella versione inglese originale dal sito di una delle autrici, Donella Meadows, a questa pagina). Il libro, come racconta attraverso la voce dei protagonisti, spaccò letteralmente in due l’opinione pubblica e la comunità scientifica internazionale. Da alcuni venne accolto come lo studio – sistematico e serio – che mancava; da altri (tipicamente: lobby dell’industria energetica, politici, una larga fetta di economisti) venne recepito malissimo. Il documentario è davvero molto interessante, una di quelle cose che tutti dovrebbero aver visto almeno una volta nella vita.
Il Club di Roma divenne. come lo è ancora oggi, una sorta di osservatorio permanente sui cambiamenti e un osservatorio soprattutto sul futuro del pianeta. A vent’anni – nel 1992 – venne pubblicato un “aggiornamento” che consisteva anche in una specie di verifica degli scenari dipinti nel 1972. Tra quelli proposti, già nel 1992 (per il libro tradotto in italiano con Oltre i limiti dello sviluppo, pubblicato da Il Saggiatore), il mondo stava già andando verso il peggiore e, a trent’anni di distanza, con I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio (tradotto solo nel 2006 in italiano, Mondadori editore) siamo già all’inarrestabilità del processo e puntiamo decisamente verso la catastrofe.
Una storia che merita senz’altro di essere conosciuta, soprattutto perché gli strumenti per correggere la rotta ci sarebbero (stati) tutti.
A occhi aperti
Sabato sera scorso, alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio è stato ospite, per la presentazione del suo nuovo libro, il direttore de «La Stampa» Mario Calabresi. Un bel libro, che viene voglia di leggere e comprare, un libro “nobile” su una professione tendenzialmente poco nobile in Italia, come quella del giornalismo (nel caso specifico: del fotogiornalismo – il libro è questo con annesso booktrailer). Ma si sa: come per tutte le categorie e sottoinsiemi arbitrari che vogliamo prendere in considerazione, c’è chi alza la media e chi l’abbassa.
Calabresi è figlio di quell’ispettore diventato ahimè celebre per essere stato ucciso da un commando della sinistra extraparlamentare 41 anni fa. Le indagini condussero, come sappiamo, ai nomi di Ovidio Bompressi, incidentalmente mio conterraneo, Giorgio Pietrostefani, latitante da molti anni in Francia, Leonardo Marino che per vedersi alleggerire la pena, confessò molte cose – anche contraddittorie tra loro, come Dario Fo ebbe modo di evidenziare in un bello spettacolo, diventato libro – e Adriano Sofri. L’uccisione dell’ispettore avvenne perché questi – responsabile della squadra politica della questura di Milano – fermato il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, come si usava dire a quei tempi con una rassegnazione e un cinismo che denotano lo zeitgeist degli anni di piombo, “lo suicidò” con un volo dal terzo piano della questura. Dopo estenuanti interrogatori, percosse, e un fermo di ben tre giorni consecutivi, in violazione ai termini previsti allora dalla legge.
Insomma: anni duri, storia dura. Mario, il figlio, mio coetaneo, cresce orfano di padre e prima dei 40 anni – in un mondo “anomalo” come quello del giornalismo italiano – diventa direttore de «La Stampa», uno dei maggiori – nel bene e nel male – quotidiani nazionali. Scrive, e pubblica nel 2007, per i tipi di Mondadori, Spingendo la notte più in là, libro che non ho letto – anche se chi lo ha fatto me ne ha parlato bene, per la visione equilibrata che il libro mostra. La sinossi del libro (tratta dal sito ibs.it) recita:
È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola puntata alle spalle del commissario Luigi Calabresi cambierà per sempre la storia italiana. Di lì a poco il nostro paese scivolerà in uno dei suoi periodi più bui, i cosiddetti “anni di piombo”, “la notte della Repubblica”. Quei due colpi di pistola però non cambiarono solo il corso degli eventi pubblici, ma sconvolsero radicalmente la vita di molti innocenti. La storia dell’omicidio Calabresi è anche la storia di chi è rimasto dopo la morte di un commissario che era anche un marito e un padre. E di tutti quelli che hanno continuato a vivere dopo aver perso la persona amata durante la violenta stagione del terrorismo. Mario Calabresi, oggi giornalista di “Repubblica”, racconta la storia e le storie di quanti sono rimasti fuori dalla memoria degli anni di piombo, l’esistenza delle “altre” vittime del terrorismo, dei figli e delle mogli di chi è morto: c’è chi non ha avuto più la forza di ripartire, di sopportare la disattenzione pubblica, l’oblio collettivo; e c’è chi non ha mai smesso di lottare perché fosse rispettata la memoria e per non farsi inghiottire dai rimorsi. La storia della sua famiglia si intreccia così con quella di tanti altri (la figlia di Antonio Custra, di Luigi Marangoni o il figlio di Emilio Alessandrini) costretti all’improvviso ad affrontare, soli, una catastrofe privata, che deve appartenere a tutti noi.
Insomma: una denuncia importante, da chi quella storia dura l’ha patita sulla propria pelle. A occhi aperti, presentato sabato sera, sembra a suo modo allargare l’orizzonte al mondo intero, sulle ingiustizie sociali e politiche che hanno costellato gli anni dai ’60 in ogni parte del globo (essendo le interviste da lui condotte a fotografi che da ogni parte del mondo arrivano). Eppure… eppure nelle parole di quel direttore c’è qualcosa che suona come falsa moneta. Perché? È presto detto: l’accuratezza dell’informazione. Più volte in questi anni mi è accaduto di leggere sul giornale torinese notizie tendenziose, quando non patentemente false, soprattutto per quella storia – sempre la stessa -, l’unica che posso dire di conoscere realmente di persona, avendola vissuta direttamente per un paio d’anni: la questione No Tav.
Calabresi con veemenza, rivolgendosi a un attento Fazio, diceva sabato – citando il suo collega Domenico Quirico, liberato qualche tempo fa dopo mesi di prigionia in Siria – che il giornalista è uno che non può permettersi il “sentito dire”, ma deve – per deontologia professionale, onestà intellettuale e chi più ne ha più ne metta – essere sul posto. Dice sostanzialmente quello che è nell’introduzione del libro (e che qui cito):
Ma questo non è un libro sulla fotografia ma sul giornalismo, sull’essenza del giornalismo: andare a vedere, capire e testimoniare. Ho scritto queste pagine , che raccontano anni di incontri, nei cinque mesi in cui il giornalista de «La Stampa» Domenico Quirico era sequestrato in Siria. Giorni in cui non potevo non interrogarmi continuamente sul senso del mio mestiere e in cui mi facevo forza con l’idea che il lavoro di un giornalista deve avere la forza e il coraggio di distinguersi da quello di un entomologo: non possiamo accontentarci – per ragioni di opportunità, comodità o sicurezza – di osservare la vita del mondo dall’alto, come si farebbe con un formicaio, aiutati magari da un’ottima lente. Un giornalista, e lo stesso vale per un fotografo, ha il dovere di vivere in mezzo alle formiche, di vedere il mondo dal loro punto di vista.
Prima di partire, Domenico mi aveva ripetuto che non puoi scrivere di un bombardamento dal confine, attraverso i racconti dei fuggitivi, non lo puoi raccontare se non hai sentito il rumore delle esplosioni, se non hai passato la notte sveglio insieme a chi sta sperando di arrivare vivo all’alba, se non hai provato la stessa paura.
Quante belle parole! Ed è buffo che si conceda tutta questa nobiltà d’animo a chi va in luoghi remoti, mentre non si è disposti a fare un passo per andare in Val Susa, per dare un’occhiata! Non serve mandarci uno con il coraggio (o l’incoscienza) di Quirico. Basta un giornalista “normale”, uno che non stia “a occhi chiusi” della specie di coloro che abbassano la media, ma uno che abbia la voglia di stare in mezzo alla gente – e non in mezzo ai poliziotti – a vedere realmente cosa succede.
Un post non è il luogo adatto per entrare nei dettagli, ma ci sono chiari episodi di mistificazione, come quello che cito qui, noto a chi frequenta la Val Susa: http://mazzetta.wordpress.com/2011/11/21/mario-calabresi-deve-spiegare/. Sì è proprio il caso di stare “a occhi aperti”, caro direttore, soprattutto contro l’ipocrisia e la retorica di certe parole. E se si vuol tessere l’elogio dei fotografi, allora anche il Movimento ha dato un contributo che non sfigurerebbe certo nel libro che lei ha appena curato: L. e C. – che non cito espressamente per questione di privacy – ma che ringrazio per il loro lavoro, hanno realizzato queste foto:
Austherity & so on…
Molte delle persone che mi conoscono sanno che non faccio mistero del mio essere schierato contro la costruzione dell’Alta Velocità in Val Susa. I motivi li ho discussi ampiamente qui e non ho intenzione di ritornarci su questo post nel quale, soprattutto, vorrei essere breve.
Da quasi un anno però non frequento la Val Susa e non sono parte attiva (se mai io lo sia stato in qualche frangente…) del Movimento No Tav. Questo però non significa che, anche solo a distanza, non continui a seguire una vicenda, la cui distanza – spaziale, soprattutto, non certo emotiva – permette di focalizzare una storia che, nei suo contorni appunto, appare grottesca che, come diceva il filosofo (Nietsche, mi pare, da qualche parte), “se non fosse tragica, sarebbe comica”. Gli spunti di comicità ci sono e sono anche tanti, ma in tempi di recessione come quelli attuali c’è davvero ben poco da ridere.
L’ultimo atto è stata questa manifestazione romana, (di cui però faccio un link qui anche al PDF, nel caso in cui il link al web venisse sostituito o non funzionasse) di un paio di giorni fa, e la cosa che mi ha colpito è come invece io sia vicino ancora, a distanza di un anno, a tutta questa faccenda: curiosamente e con una certa serendipity la persona ritratta in foto è un mio conoscente, Antonio, celebre nel movimento soprattutto in Toscana. Una bella persona, d’altri tempi, di quelle che vanno al sodo delle questioni, alle quali i giri di parole non piacciono tanto. Anzi gli piacciono così poco che per aver espresso quel che pensava ha passato dei guai.