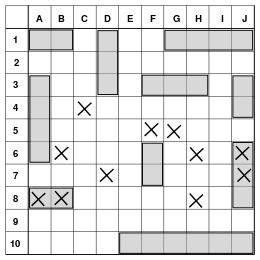Se guardo un po’ lucidamente ai percorsi che mi avvicinano alla e respingono dalla Filosofia, comincio a individuare – alla non giovane età di 48 anni – i motivi di tali avvicinamenti e repulsioni. Chi mi conosce conosce anche i tortuosi percorsi intellettuali che mi hanno condotto da una scuola (superiore) tecnica (ITIS) a frequentare, senza profondi convincimenti, un anno e mezzo di ingegneria con il misero bottino di due esami all’attivo e una frustrazione al limite dell’esaurimento nervoso (perché va bene “lacrime, sangue e sudore” ma col senno di poi gli anni della selezione a Ingegneria, a Pisa, negli anni accademici intorno al 1990, erano di fatto il setaccio, fine all’inverosimile, utile a buttare fuori le persone – che pure diligentemente avevano studiato – dagli esami a ogni occasione possibile). Da lì transitai a Filosofia e, pur con l’andamento altalenante di chi ha da guadagnarsi da vivere e risulta all’anagrafe accademica come lavoratore-studente, mi laureai (tardi).
Se guardo un po’ lucidamente ai percorsi che mi avvicinano alla e respingono dalla Filosofia, comincio a individuare – alla non giovane età di 48 anni – i motivi di tali avvicinamenti e repulsioni. Chi mi conosce conosce anche i tortuosi percorsi intellettuali che mi hanno condotto da una scuola (superiore) tecnica (ITIS) a frequentare, senza profondi convincimenti, un anno e mezzo di ingegneria con il misero bottino di due esami all’attivo e una frustrazione al limite dell’esaurimento nervoso (perché va bene “lacrime, sangue e sudore” ma col senno di poi gli anni della selezione a Ingegneria, a Pisa, negli anni accademici intorno al 1990, erano di fatto il setaccio, fine all’inverosimile, utile a buttare fuori le persone – che pure diligentemente avevano studiato – dagli esami a ogni occasione possibile). Da lì transitai a Filosofia e, pur con l’andamento altalenante di chi ha da guadagnarsi da vivere e risulta all’anagrafe accademica come lavoratore-studente, mi laureai (tardi).
Seguii la mia strada (master Sissa in Comunicazione della Scienza, qualche anno dopo) nella convinzione (1) che fosse tardi per qualunque vocazione accademica (poi già avevo un lavoro ed ero fuori tempo massimo) e che dunque (2) vi fosse la necessità di specializzarsi, visto che la Filosofia è tutto fuorché una specializzazione in sé (nonostante abbia molte declinazioni: del linguaggio, delle religioni, analitica, ecc.).
Ne presi le distanze seguendone da outsider (quale sono) le tracce che rimanevano nelle mailing list (per fare un esempio) della SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) nella quale si dava conto dei vari convegni, delle scuole, dei bandi di dottorato ecc., rimanendo di volta in volta sempre più perplesso per il tenore degli argomenti (che nella mia mente – per carità, forse non sufficientemente preparata e filosofica – suonavano letteralmente come il vuoto nulla) intorno ai quali si riuscivano a organizzare convegni, workshop e quant’altro vi possa venire in mente. Insomma: il respingimento e il punto di allontanamento massimo da una disciplina che pure mi aveva entusiasmato nella sua declinazione antica e classica (il mondo greco dei “fondamentali”, dai presocratici – Anassimene, Anassimandro, Democrito, Leucippo di cui studiai l’atomismo – alla triade Socrate, Platone, Aristotele) e mi aveva intrigato intellettualmente con figure moderne e contemporanee quali quelle di Wittgenstein in primis, ma anche Heidegger e altri.
Eppure nella sua accezione odierna nel migliore dei casi mi pareva che la Filosofia proponesse lo scimmiottare il pensiero dei grandi, la “riflessione della riflessione” e tutto ciò che comporta il deterioramento e l’assenza di un pensiero originale: da qui l’aver sempre voluto coltivare la passione per la scienza dove, almeno, si parlava di qualcosa e si tentava di risolvere qualche problema (ai miei occhi: vero o almeno ben più concreto di quelli che la Filosofia – nei suoi territori accademici nostrani – ha teso (e ahimè tende a) propormi).
Tutto questo ovviamente nel contesto più ampio della vita – i cui margini e spazi per gli studi risultano sempre più sacrificati e solo il “rocambolesco” di cui la mia è stata costellata, mi ha permesso (non senza sacrifici) gli spazi per qualche approfondimento. Così il “rocambolesco” volle che vinsi nel 2011 un concorso al Consiglio Nazionale delle Ricerche e il riaccostamento verso la hard science fosse in una qualche misura più definitivo e perentorio. Nella mia formazione seguì un (secondo) master (2013) di primo livello in “Tecnologie Internet”, guarda caso organizzato da quella stessa facoltà (Ingegneria) che mi aveva respinto così duramente più di vent’anni prima. Adesso che sto completando il ciclo di studi del dottorato (presso quale facoltà? Ingegneria, naturalmente, ma a Trento) sono accadute due cose “strane” (ma forse neppure troppo): (1) ho, negli anni di questa frequentazione trentina, allacciato i rapporti con esponenti dell’AISC (Associazione Italiana di Scienze Cognitive) perché mandai un mio modesto contributo per un convegno e da quel momento sono stato cooptato (anche e soprattutto sul piano umano) in questa dimensione (la mia tesi di laurea sconfina ed esplora non poco le Scienze Cognitive) e (2) sto leggendo in questo periodo un (bel) libro: Il tempo degli stregoni, di Wolfram Eilenberger.
Questo libro, che ha come sottotitolo: 1919-1929: le vite straordinarie di quattro filosofi e l’ultima rivoluzione del pensiero, mi ha dato modo di riflettere più chiaramente su questo mio “percorso intellettuale”, soprattutto quando l’autore – dalla scrittura vivace e capace di mescolare sapientemente il dato biografico dei 4 (Wittgenstein, Cassirer, Heidegger e Benjamin) e i loro percorsi intellettuali – scrive (proprio parlando del Tractatus di Wittgenstein):
Lo spazio del dicibile, di cui l’opera di Wittgenstein traccia i confini “dall’interno” con i mezzi dell’analisi logica del linguaggio, riguarda solo il mondo dei fatti, l’unico ambito del quale si possa parlare in modo sensato. Comprendere con la massima esattezza possibile questo mondo dei fatti e la sua struttura è però in ultima analisi il compito delle scienze naturali. Ossia, Wittgenstein ne è convinto, “qualcosa che non ha nulla a che fare con la filosofia” (6.53 [del Tractatus]). Il problema, o meglio la soluzione vera e propria del problema, starà dunque, su questo sfondo, nella seguente convinzione, o per meglio dire, nel seguente stato d’animo:
6.52 Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa la risposta.*
La Satz 6.52 del Tractatus è, per me, nota ed è stata, in passato, l’epifania di quanto molti che frequentano o hanno frequentato le scienze dure “soffrono” (soprattutto in quella delicata fase della vita post-adolescenziale che va dai 19 ai 25 e traghetta gli individui verso l’età adulta), vale a dire: l’avere a che fare con discipline che possono risultare sterili per l’animo umano. Una giornata di studio della Chimica, della Fisica, dell’Analisi Matematica dice qualcosa di un mondo oggettivo che sta fuori di noi, su come funziona e su quali sono i suoi “fatti”, per dirla con Wittgenstein, ma nulla dice su qualcosa che possa aiutare a decodificare sensazioni, sentimenti, stati d’animo, qualcosa che sia utile a un confronto e possibilmente a una crescita interiore dell’individuo: nessuno dei “nostri problemi vitali” viene toccato. Da qui il secondo moto oscillatorio del pendolo che, di senso contrario al primo, mi ha respinto dalle scienze dure per farmi tornare a quelle umane. Il programma di Wittgenstein in un mondo – ora come allora – “positivista” ed erede dell’età dei Lumi è quindi “esistenzialista”, in un certo qual modo (come del resto afferma l’autore del libro nella pagina successiva).
La Filosofia – se non come ancella della scienza – è quindi “morta”? Qualche pagina dopo Eilenberger – stavolta parlando di Heidegger – scrive:
Se infatti si decide per la “assoluta fattualità”, e si delega la questione del “c’è” alle scienze naturali, la filosofia va incontro allo stesso destino pronosticato da Wittgenstein: diventa superflua, e si riduce tutt’al più al ruolo di ancella delle scienze naturali. Ma può succedere di peggio: cioè che la filosofia degeneri in quella sorta di vuota chiacchiera basata su un falso fondamento valoriale carico di pregiudizi, che Heidegger associa all’idea della filosofia come “visione del mondo”.**
Resta, in me e per me, questa specie di oscillazione perché, a oggi, a meno di declinazioni “mistiche”, la Filosofia, si è fatta o vuota chiacchiera o, come detto nella migliore delle ipotesi, ancella. In un momento di urgenza mondiale legata alle questioni di cui molti di noi sono a conoscenza (o che ignorano perché è molto più comodo farlo che preoccuparsi, vale a dire: crisi economica, ecologica ed energetica), essa dovrebbe smettere di essere l’una e l’altra cosa, per farsi bussola di una Umanità che sembra aver completamente perso il senso del suo stare su questo Pianeta.
* Eilenberger, p. 51.
** Eilenberger, p. 61.
PS: questo libro – di cui sto ultimando la lettura – è molto bello per diversi motivi, ma il suo fascino principale risiede nel fatto di vedere mescolati elementi che di solito nei libri stanno distinti: sketch biografici, aneddoti (devo dire sempre piuttosto interessanti, come l’incontro tra Cassirer e Warburg o le note trasformazioni del Wittgenstein che da autore del Tractatus diviene maestro elementare, aiuto giardiniere in un monastero e infine architetto per la costruzione della casa della sorella a Vienna, prima di riapprodare alla Filosofia e al fecondo periodo che sfociò in quel bel volume postumo che sono le Ricerche filosofiche…), pezzi della vita dei protagonisti che, intevitabilmente si intrecciano con la Storia dell’Europa di quel tempo e… ovviamente il pensiero che sta alla base dell’agire dei quattro. Davvero complimenti all’autore che ho scoperto essere ospite del Festival Filosofia di quest’anno, qui.