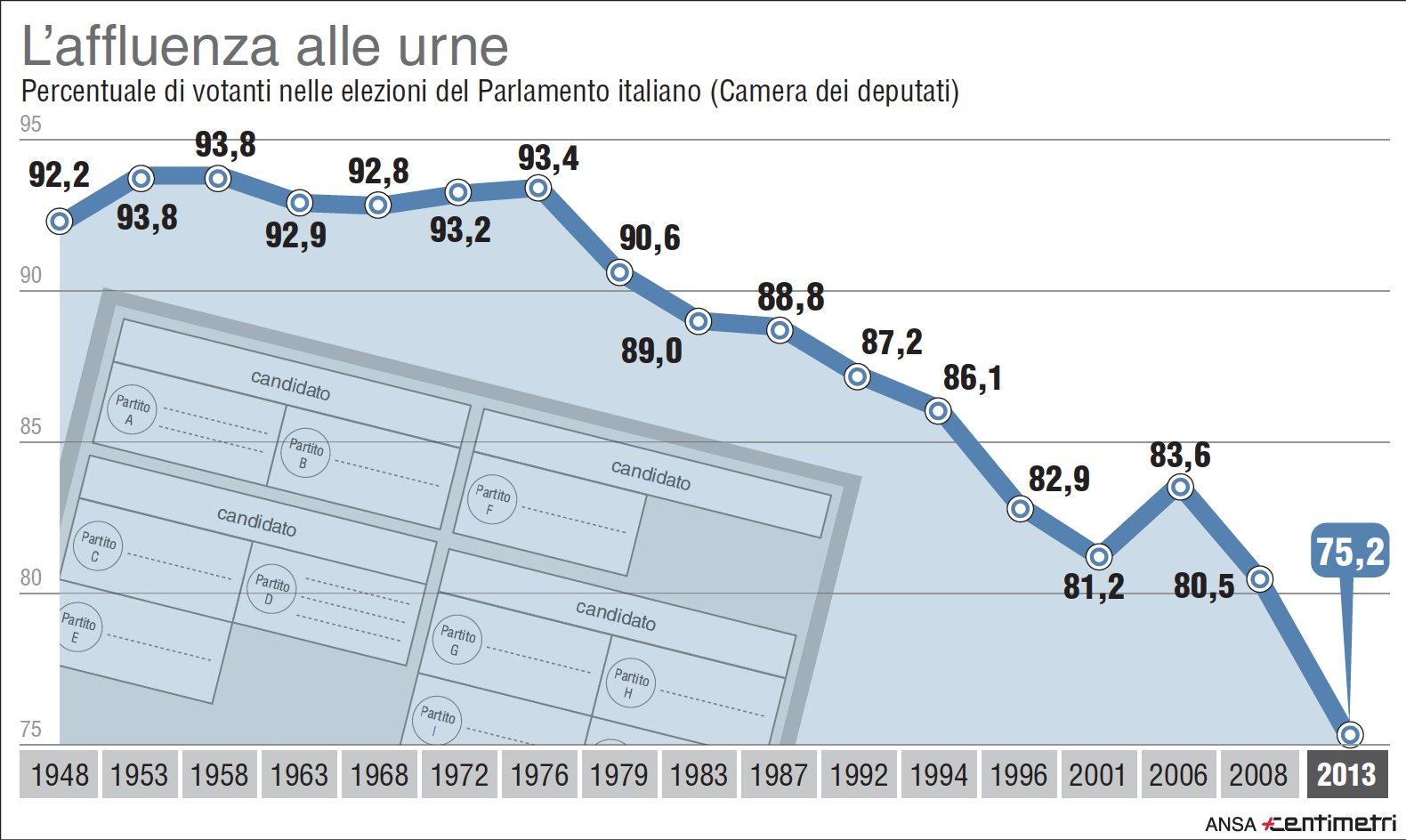Finalmente venerdì sera scorso sono riuscito ad andare a vedere, al cinema estivo, “Io capitano“, il film di Matteo Garrone. La storia, le storie, assurde e tormentate di questi esseri umani – che dovremmo considerare in quanto tali, nostri fratelli – le conosciamo. Le conosciamo non da ieri, ma da un bel po’, anche se le abbiamo dimenticate o meglio: lasciate collettivamente a prendere polvere nei recessi più remoti delle nostre coscienze. Qui mi fermo per evitare di sembrare (o essere) retorico – cosa nella quale è facile cadere quando si trattano questi argomenti.
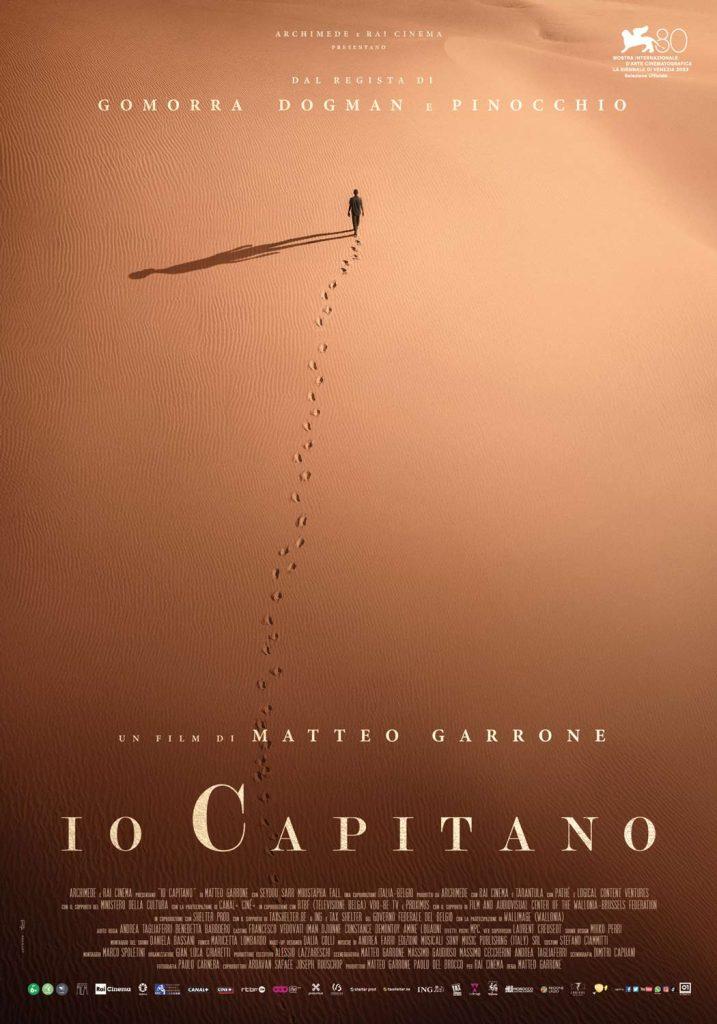
La locandina del film
Però il film è importante. Ed è importante perché intanto toglie un po’ di quella polvere e ci fa vedere quello che solo nella stragrande maggioranza dei casi possiamo immaginare per averne letto qualche reportage (o meglio: quelli che di noi hanno coltivato questa sensibilità magari hanno fatto). Il film è importante perché inscena le reali odissee di generazioni anche di giovanissimi (i protagonisti del film hanno 16 anni) che tentano miglior sorte, per sé e la propria famiglia. La parola “odissea” non è scelta a caso: secondo me la narrazione cinematografica si fa a tratti epica: all’anabasi interna al continente africano, in cui chi decide di intraprendere il viaggio deve resistere a prove psichiche e fisiche letteralmente infernali, segue il percorso opposto che dall’interno conduce verso nord, verso l’ultima – anzi la penultima – forca caudina: la Libia… (l’ultima, prima dell’accesso nella “Fortezza Europa”, è costituita dalle placide, ma al contempo insidiosissime, acque del Mediterraneo). Solo lì, dove il film si conclude, c’è il punto di congiunzione tra le cronache che distrattamente vediamo e ascoltiamo e la fine di quella storia che il film ha il merito di mettere in luce a partire da dove ha origine.
Il protagonista Seydou Sarr diventa – dopo le mille rocambolesche peripezie del caso e l’inquietante scorcio sui centri di detenzione (vere e proprie prigioni) libici – realmente il capitano di una di queste bagnarole. Costretto dalle contingenze (ormai “il peggio è passato”, forse, e il cugino bisognoso di cure che paradossalmente sono più vicine di là dal mare che non in Libia…), nonostante tenti di ribellarsi ai trafficanti che lo sottopongono a quel carico di responsabilità, alla fine di un corso accelerato di 10 minuti – in cui gli spiegano come usare la manetta dell’acceleratore e la leva di fianco di “avanti” e “indietro”, mantenendo il timone in direzione nord, segnato dalla bussola di bordo – queste responsabilità se le assume, per sé, per il cugino, per tutti coloro (come sempre: tanti e oltre ogni immaginabile capienza) che saliranno sull’imbarcazione. E, viene da aggiungere, il ragazzo ha spalle talmente capaci, nella sua gioventù, nella sua incoscienza, da assumersi implicitamente anche le responsabilità di tutti coloro che, a partire dalla politica, scendendo fino all’ultimo dei trafficanti, questo gioco lo permettono (e ne sono i veri responsabili).
Guardando le ultime scene del film non ho potuto non pensare che la prima telefonata di SOS, inoltrata alla guardia costiera maltese (buoni quelli!) – visto che in quelle acque territoriali si trovavano – avesse come esito, non la fine dell’odissea, ma solo la penultima tappa: i maltesi se ne fregano e quelli stanno lì a giornate ad aspettare che qualcuno gli presti soccorso. Ma il ragazzo è pronto di spirito: ha giurato a se stesso che nessuno sarebbe morto per causa sua e capisce che questi non arriveranno mai. Allora decide di continuare – la “benevola” finzione cinematografica fa sì che il carburante non finisca, cosa che invece nella realtà spesso succede – fino a quando non approda alle acque territoriali italiane. Non sappiamo quale sia il periodo in cui la pellicola è ambientata, ma non dimentichiamo che, fuori dalla finzione cinematografica, abbiamo avuto un bell’intervallo il cui titolare del nostro ministero dell’interno (le maiuscole e le minuscole in questo caso indicano la variabilità: come in ogni sottoinsieme arbitrariamente deciso, c’è chi alza la media e chi l’abbassa…) è stato Matteo Salvini. Salvini di cui leggevo, in un recente libro (La lingua della neopolitica) non sa neppure cosa significhi il termine frugale (in relazione a quei Paesi nordeuropei – Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi – che sono a favore di un rigore fiscale senza deroghe):
L’aggettivo è stato anche sostantivizzato, come ha fatto Matteo Salvini in un tweet del 19 luglio: «Ma che ne sanno i “frugali”? Mozzarella e panzerotti pugliesi, olio buono, frutti di una terra stupenda che tutto il mondo ci invidia. Orgoglio italiano, sempre!» (op. cit., p. 123)
Di certo con l’orgoglione (pardon: orgoglioso) Salvini al comando, la cui demagogia va oltre il professionismo, la paradigmatica storia di Seydou Sarr e dei suoi sodali possiamo immaginare non avrebbe avuto un lieto fine.
Consolante che l’arena fosse gremita. Segno che questo è un tema da cui le persone sono (ancora) toccate. Per altro l’emigrazione africana è in qualche modo un “classico” che non esclude altre migrazioni dall’Est del mondo – afgani, pakistani, curdi, bengalesi… tutta un’umanità che fugge da condizioni sempre più proibitive.