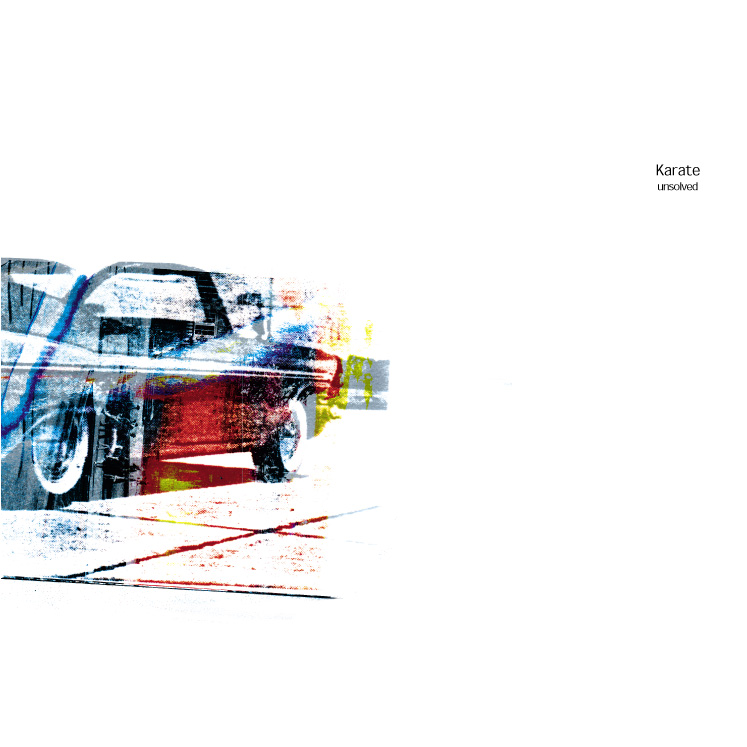Del tedesco – che pure dilettantescamente studiai in anni passati, affascinato da questo trasloco culturale della filosofia che, dopo aver parlato greco (antico) di fatto si trasferì in Germania (insieme alla fisica…) – non ricordo praticamente nulla, salve qualche folgorante assonanza di termini, di etimi, come quello del titolo. Leben è “vita” ed Erleben (che sembra contenere la stessa parola nel suo interno) è esperienza.
Di fatto quindi non si dà vita senza che vi sia esperienza che la sostanzi (senza che vi sia un “esperire”, in quella accezione peculiare che anche nella nostra lingua ha il termine) così come è possibile dare una lettura dell’equazione in senso contrario: senza (fare) esperienza (/esperire) non c’è vita.
Forse la più alta vetta poetica di questo concetto la si ritrova in un celebre brano di (guarda caso, un tedesco!) Rainer Maria Rilke, e in particolare nel celebrissimo «I quaderni di Malte Laurids Brigge». Rilke fa scrivere al suo alter ego una riflessione sul fare poesia, che è poi una riflessione sulla vita:
Bisognerebbe saper attendere e raccogliere, per una vita intera e possibilmente lunga, senso e dolcezza, e poi, proprio alla fine, si potrebbero forse scrivere dieci righe valide. Perché i versi non sono, come crede la gente, sentimenti (che si acquistano precocemente), sono esperienze. Per scrivere un verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, bisogna capire il volo degli uccelli e comprendere il gesto con cui i piccoli fiori si schiudono al mattino. Bisogna saper ripensare a sentieri in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e congedi previsti da tempo, a giorni dell’infanzia ancora indecifrati, ai genitori che eravamo costretti a ferire quando ci porgevano una gioia e non la comprendevamo (era una gioia per qualcun altro), a malattie infantili che cominciavano in modo così strano con tante profonde e gravi trasformazioni, a giorni in camere silenziose, raccolte, e a mattine sul mare, al mare soprattutto, ai mari, a notti di viaggio che passavano alte rumoreggianti e volavano assieme alle stelle, e non basta ancora poter pensare a tutto questo. Bisogna avere ricordi di molte notti d’amore, nessuna uguale all’altra, di grida di partorienti e di lievi, bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche accanto ai moribondi bisogna esser stati, bisogna essere rimasti vicino ai morti nella stanza con la finestra aperta e i rumori a folate. E ancora avere ricordi non basta. Bisogna saperli dimenticare, quando sono troppi, e avere la grande pazienza d’attendere che ritornino. Perché i ricordi in sé ancora non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, anonimi e non più distinguibili da noi stessi, solo allora può darsi che in una rarissima ora si levi dal loro centro e sgorghi la prima parola di un verso.
Sono parole formidabili, che, a proposito di ricordi, io ho dimenticato (ma poi, come si vede me ne sono ricordato), ma che forse dovremmo trascrivere su un pezzo di carta e mettercele, che ne so, dentro il portafoglio, in mezzo alle banconote, come antidoto alle banconote stesse, usate per lo più per acquistare oggetti (quindi, come dice saggiamente una mia giovane cognata: “meno oggetti e più esperienze”).
Ma c’è una cosa curiosa che riguarda la mia famiglia – perché queste parole che ho cercato e ritrovato sono riaffiorate alla mia memoria nei giorni scorsi durante l’ultima visita ospedaliera a una mia zia, novantunenne, sorella più anziana di mio padre. Una cosa curiosa che riguarda proprio queste esperienze («Ma anche accanto ai moribondi bisogna esser stati, bisogna essere rimasti vicino ai morti nella stanza con la finestra aperta e i rumori a folate») che la mia famiglia – nella fattispecie nella figura di mio padre, suo fratello – non vuole e non ha voluto fare, dicendo che preferiva ricordare la sorella com’era nei giorni prima del ricovero quando, ancora lucida, era a casa (il ricovero è avvenuto per un attacco ischemico). Comprensibile e forse anche condivisibile: ognuno a certi eventi luttuosi reagisce come sa e come può.
L’ultima parola che in tedesco sta in questo titolo è infatti “morte” e sta in contrapposizione alla “vita” e al suo “fare esperienza”. Mia zia è morta questa mattina presto. Una morte “annunciata” ieri dal collasso di alcuni organi che hanno smesso di funzionare. Non so se la mia scelta di andarla a trovare in ospedale un’ultima volta – che si contrappone a quella di mio padre – vada nella direzione della vita, del fare esperienza nel senso descritto da Rilke, ma la visione di questa donna con la quale non credo di essere riuscito a comunicare (io con la mascherina FFP2, lei con la mascherina dell’ossigeno, in uno stato di coscienza non chiaro) non mi ha sottratto nulla, anzi.
L’esserci guardati ancora per qualche momento negli occhi (avrà capito? sapeva dov’era? sapeva chi ero?), percepire il suo battito cardiaco accelerato credo sia stato importante per me; non so dire se di conforto, pur minimo, per lei. So che provava affetto nei miei confronti, io che porto il nome di suo padre. Poi c’è questo particolare, il particolare di un tempo che fu. Antico, che mi riporta al mio essere bambino. Mia zia è di quella generazione di donne (e prima di lei, sua madre, mia nonna) che usava portare i capelli lunghissimi. E se dico lunghissimi, intendo proprio lunghissimi, ma che ovviamente nessuno di noi ha mai visto sciolti, perché in pubblico vigeva – ed è sempre stata in auge – la “crocchia”, o chignon. Ho il vago ricordo – talmente vago che non so dire se fosse mia zia o mia nonna! – di bambino, di una volta che assistetti, per puro caso, a un lavaggio di chioma che fu, si può immaginare, piuttosto impegnativo. Ero impressionato da quella massa così lunga e voluminosa che, una volta attorcigliata, non sembrava affatto potesse nascondere una tale cascata di capelli.
Ecco, nel trambusto ospedaliero, nell’urgenza del momento, nelle cure che pure si devono e si danno a persone nella sua condizione, lo chignon aveva perso la sua forma e i capelli stavano poggiati sul cuscino, sciolti, su un lato, mitigando quella specie di austerità che la regola sociale imponeva, lasciando così trasparire una fragilità, una sorta di “nudità”, nell’abbandono che tutti abbiamo di fronte alla morte, quando arriva il nostro momento.