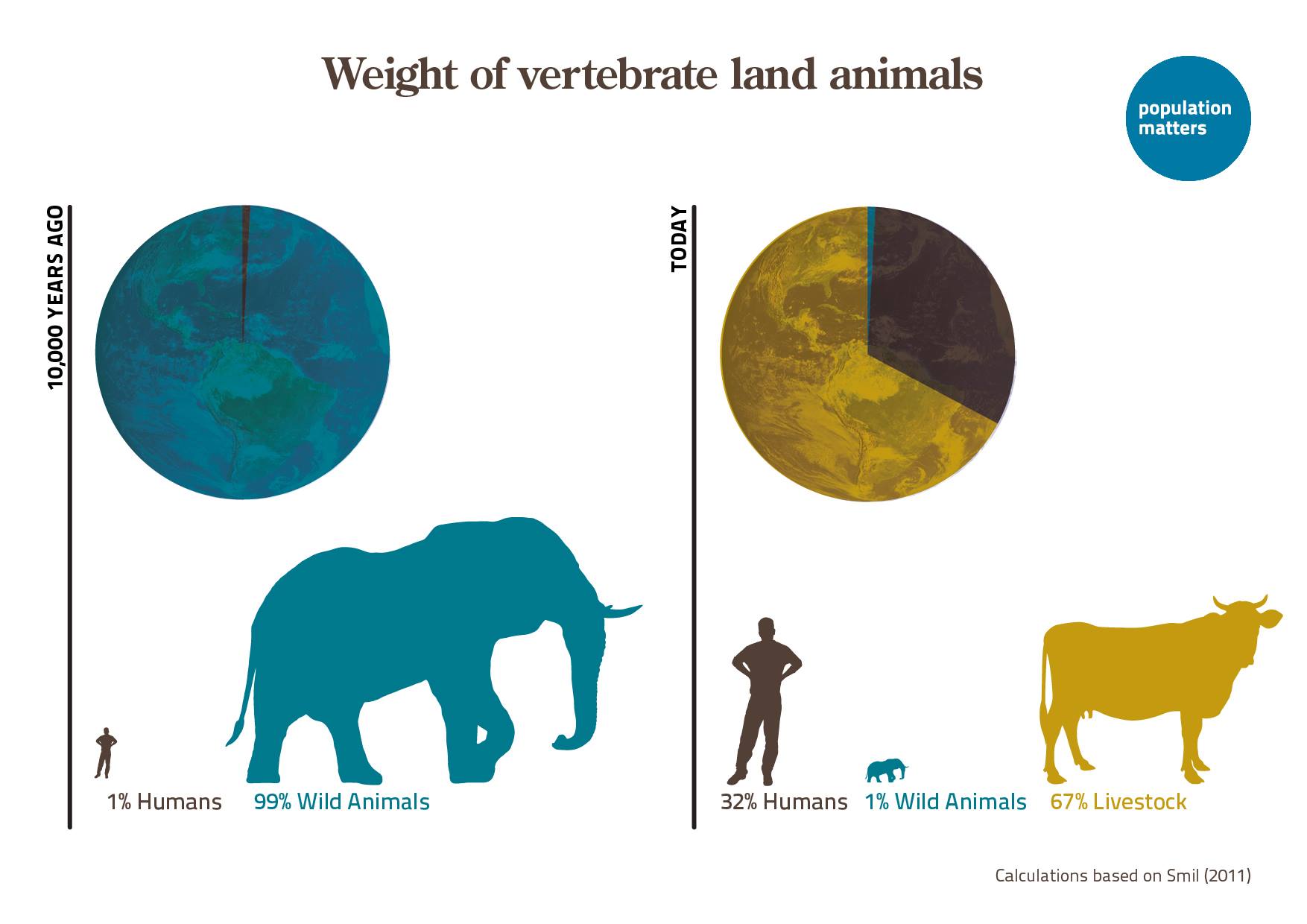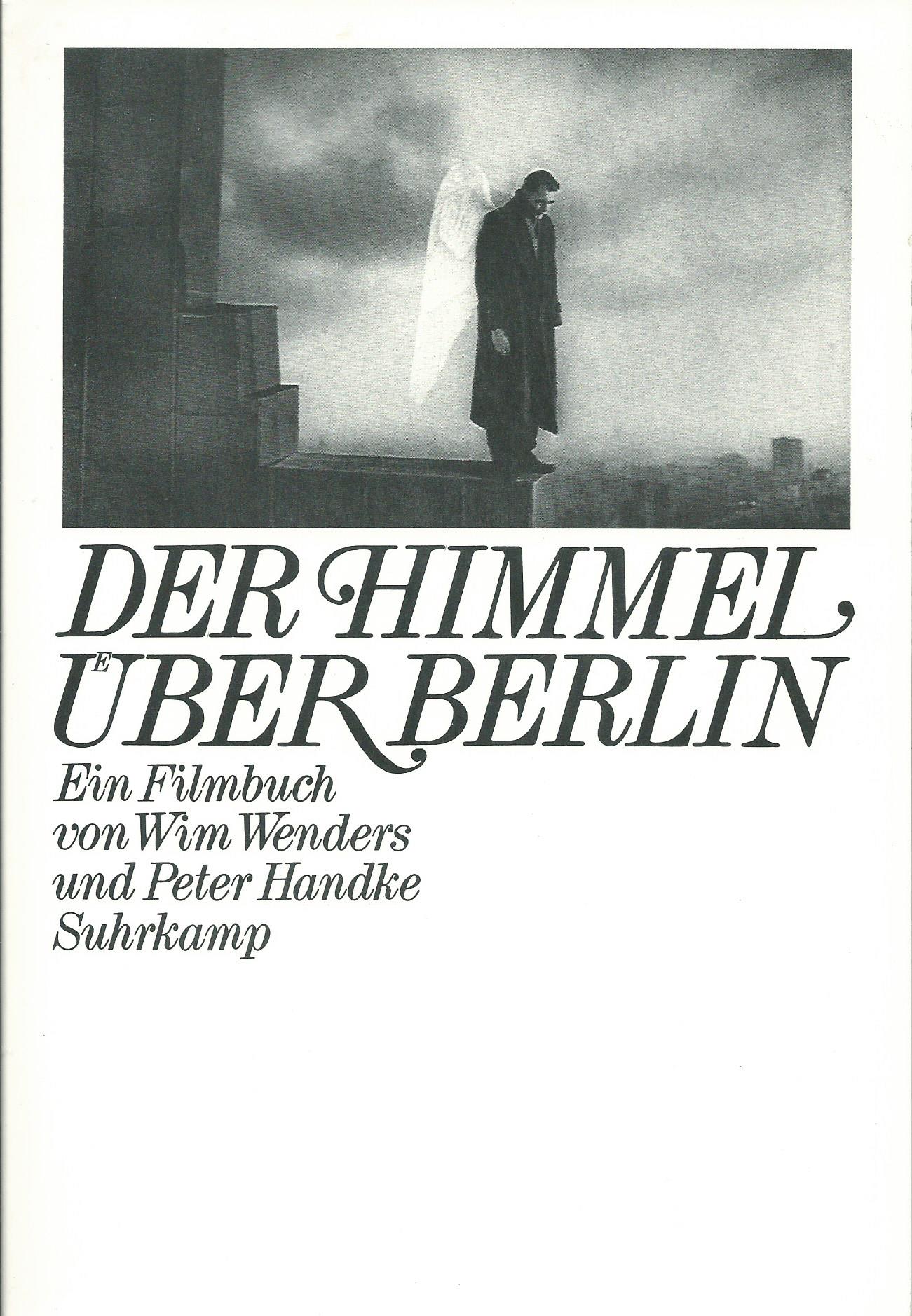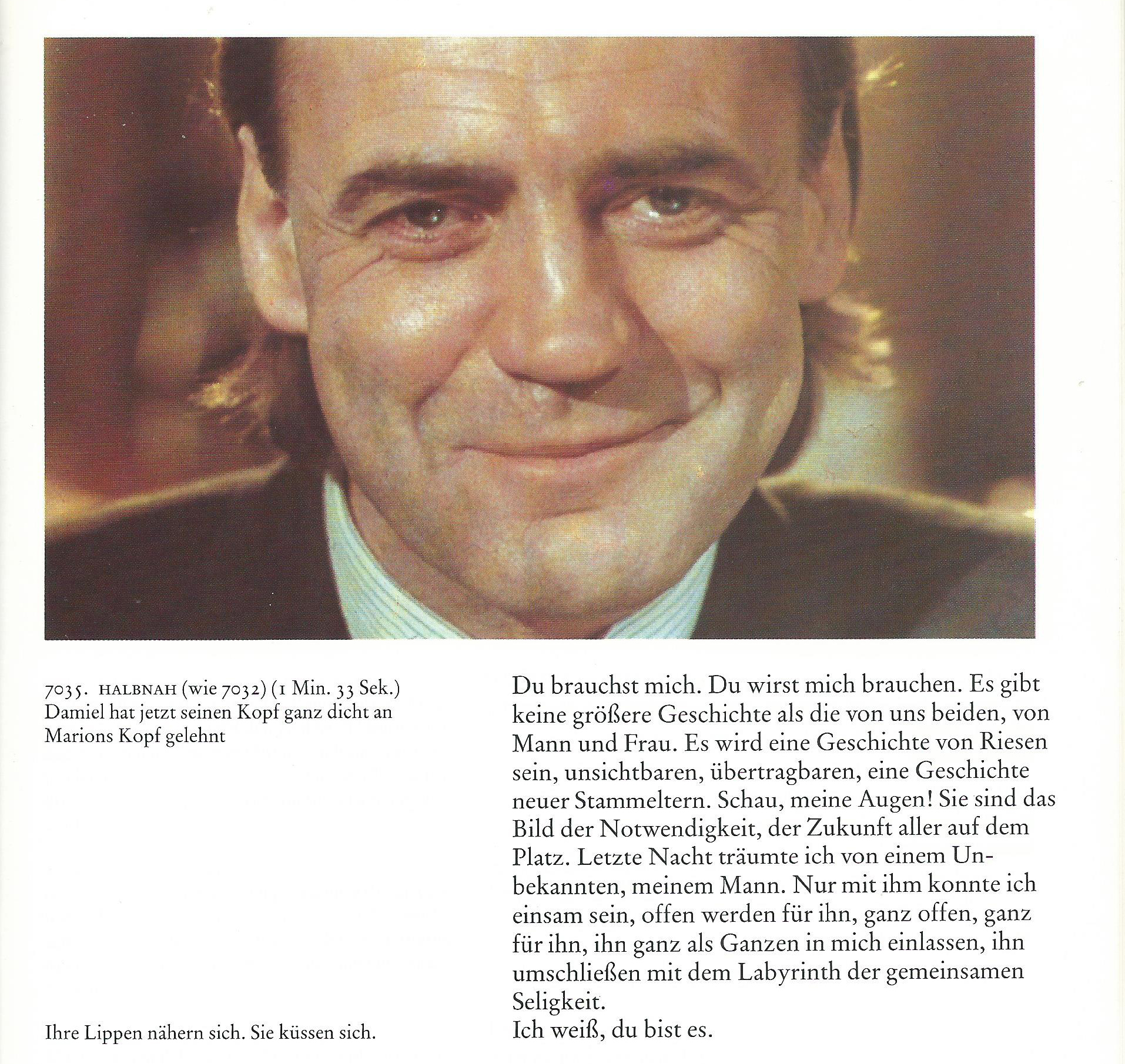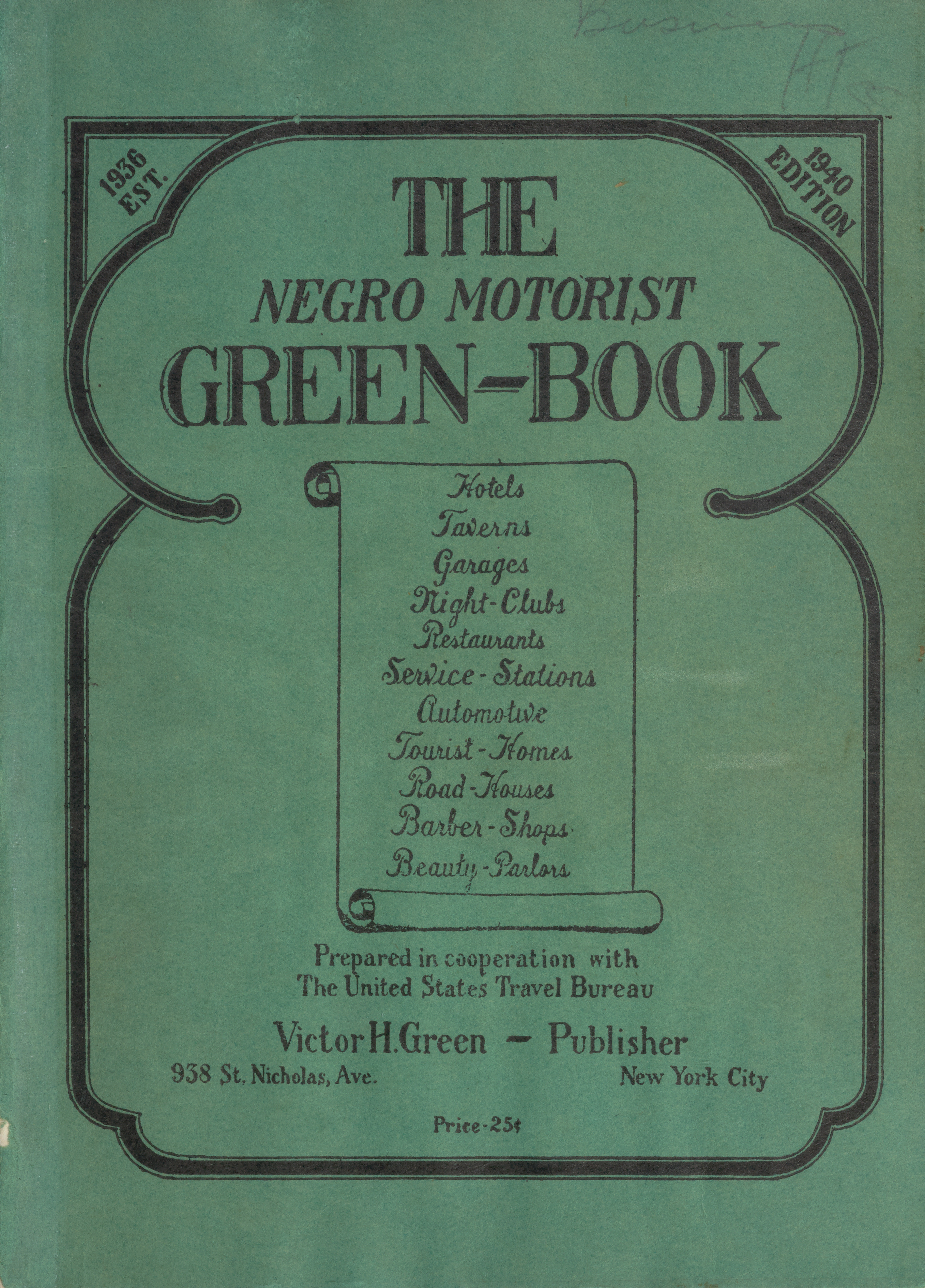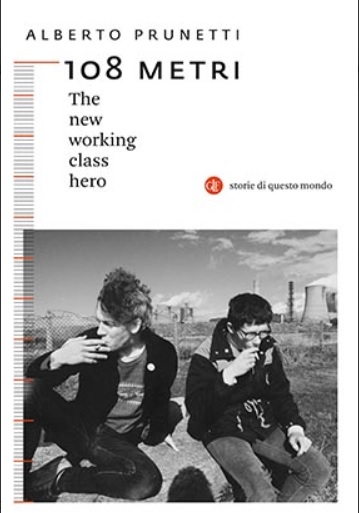Un paio di ottimi recenti articoli (anzi: un articolo e un post, per essere precisi) e qualche “comportamento di massa” mi spingono a scrivere queste righe. Parto dai comportamenti, rilevati, per altro, anche altrove (per fortuna). Uno proprio oggi, al programma televisivo nazional-popolare “Quelli che il calcio” – non guardo la TV MAI, ma, al desco parentale della domenica, si è costretti a subire il tubo catodico, trasformatosi in griglia led, ma ci siamo capiti – dove nel duo Luca e Paolo, quest’ultimo interpreta il leader del movimento (o come lo si vuol definire) delle “sardine”, Mattia Santori, con una caricatura che m’è parsa francamente del tutto gratuita, a dimostrazione che qualsiasi cosa esca ormai dagli schemi prefissati e preordinati – soprattutto quando pacifico e (ancora) difficilmente etichettabile – fa paura allo status quo, sembra essere una minaccia e, non potendo attaccare frontalmente il nuovo che avanza, per cautelarsi, nel frattempo, lo si sbeffeggia. Questa l’impressione generale.
Impressione che si trasforma in certezza nel caso Thunberg: non solo i professionisti della “macchina del fango” nel nostro misero (culturalmente) Paesello continuano ad accanirsi contro la ragazzina svedese, ma anche alcuni “insospettabili”, come i conduttori de “La barcaccia”, il programma di Radio 3 che si occupa di musica lirica, che ha la caratteristica della stroncatura (i conduttori sembrano Statler e Waldorf dei Muppet Show).
La madre di Greta, Malena Ernman, è infatti un mezzosoprano e i due conduttori, Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, non hanno perso occasione, in una delle puntate andate in onda nei giorni scorsi, non solo di trattare con la solita “sufficienza” la madre ma anche, con questo pretesto, di parlare con evidente tono canzonatorio della figlia.
Il proverbio (che si vuole cinese, ma qualunque ne sia la nazionalità è ormai patrimonio del mondo – o dovrebbe esserlo) dice che «quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito». Un modo come un altro per continuare a non vedere il problema che tutti abbiamo e che causerà molte indicibi sofferenze, mentre la conferenza sul clima di Madrid si sta trasformando in un clamoroso fallimento (francamente mi sarei stupito del contrario, ma questa mia convizione richiederebbe almeno un altro post…) e l’amico e professore di Geologia all’Università di Padova, commenta così uno scambio su una delle liste cui sono iscritto:
cari amici
le cose stanno peggio di quello che ha scritto Giovanni, perché nello Special Report IPCC su 1,5°C uscito circa un anno fa, si legge che avevamo circa 10 anni per tentare di rimanere entro quel volore di aumento, diminuendo da allora al 2030 le emissioni di CO2 di circa il 6% annuo. In realtà c’é anche scritto che le probabilità di riuscirci
sarebbero state del 66%. Chiaramento ormai è andata, dobbiamo preoccuparci dei +2°C, ma anche questo valore sembra impossibile da raggiungere, se le emissioni aumentano anziché dimunuire. Quindi siamo sulla traiettoria dei +4 °C entro fine secolo, sempre che la faccenda non acceleri per via del rilascio incontrollabile del metano dalla tundra artica.
Il fallimento della conferenza di Madrid non lascia speranze.
Riguardo alle emissioni vulcaniche, bisogna considerare che a breve termine (2 anni) prevale l’effetto Pinatubo (eruzione del 1991), cioé il raffreddamento, a causa dell’emissione di ceneri che schermano la radiazione solare. Non a caso il processo di geoingegneria che prevede di diffondere particelle solfatiche nella stratosfera con missili o aerei si chiama appunto effetto Pinatubo.
Perché la CO2 vulcanica conti ci vorrebbero supereruzioni continue della durata di migliaia di anni tipo LIP (large igneous province) avvenute in passato e che han prodotto estinzioni di massa.
E con questo “passo e chiudo”.