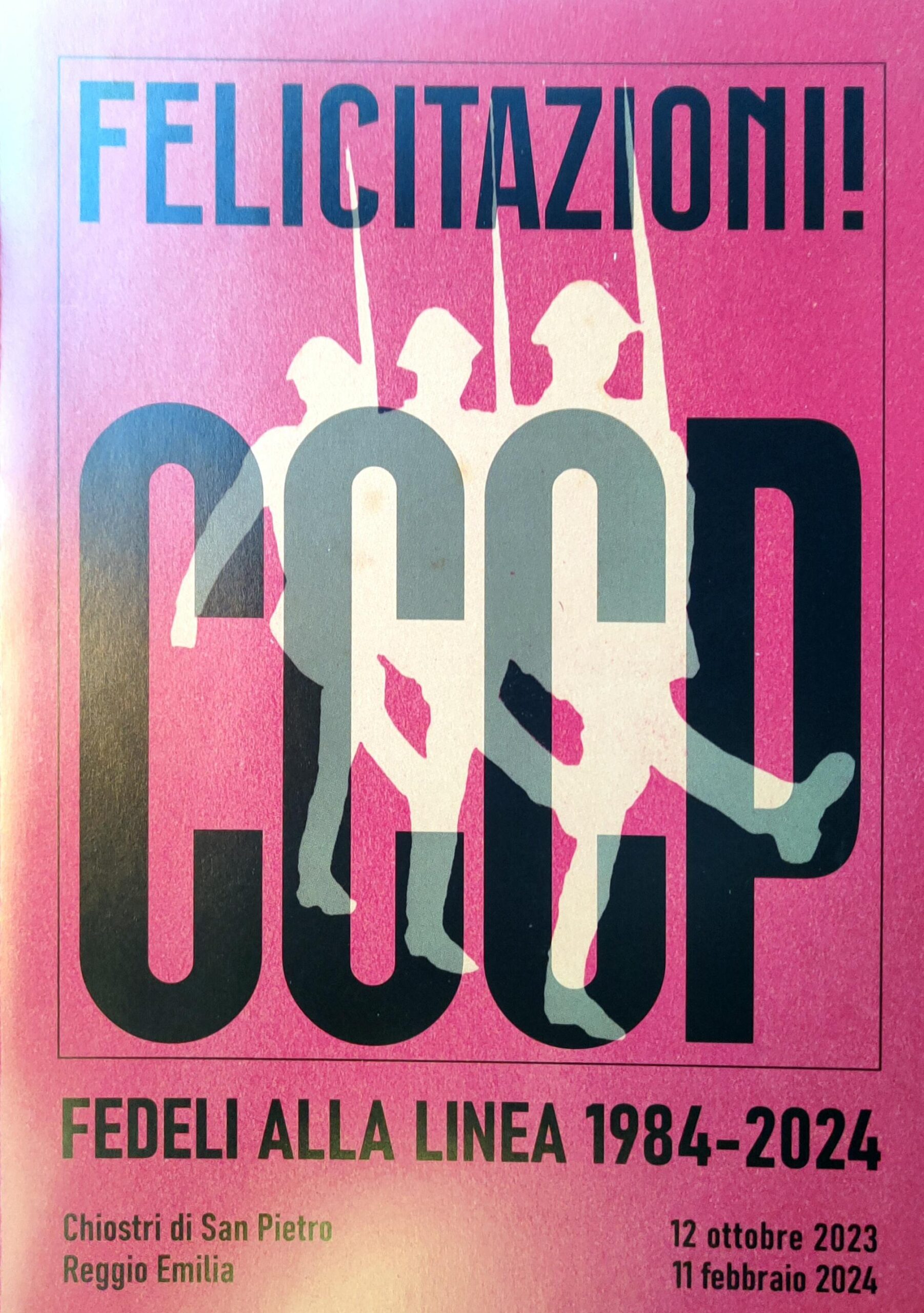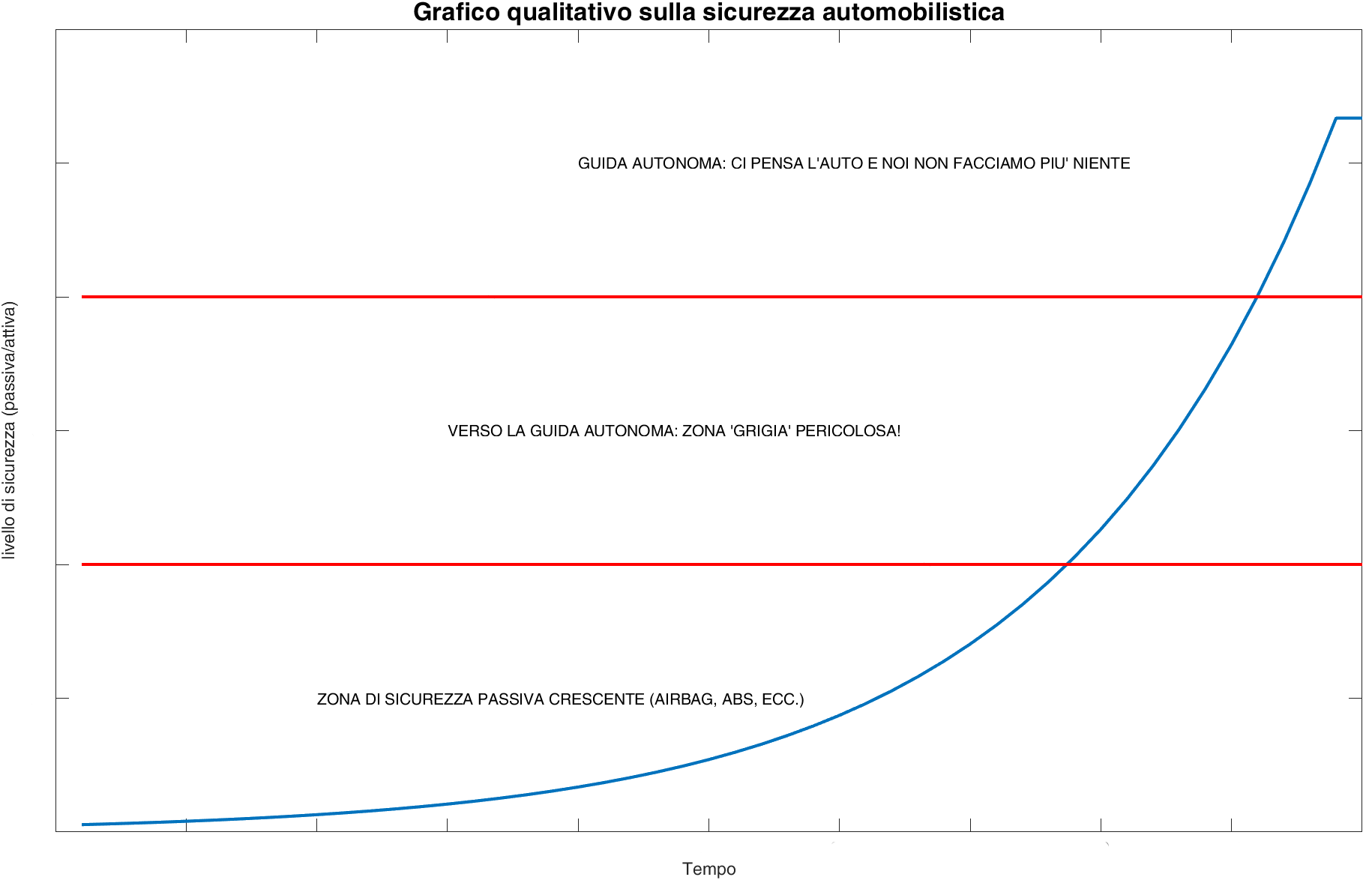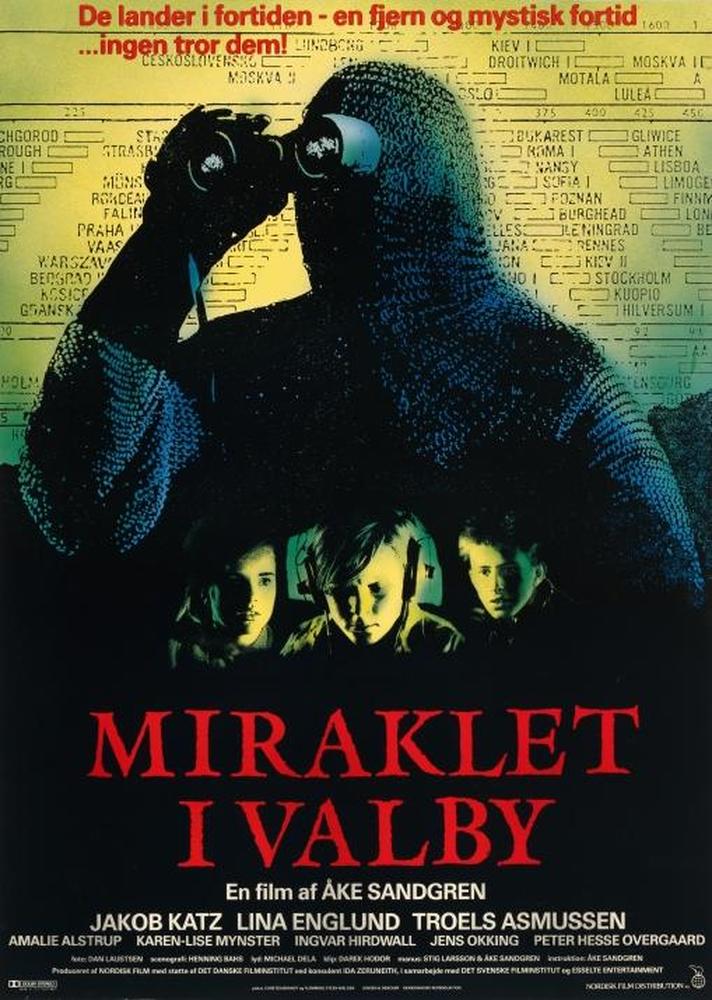Avrei voluto scrivere nel titolo: «per la nascita, la dissoluzione, la trasformazione» dei CCCP. Insomma: panta rei, tutto scorre, e nulla è immutevole, nonostante la “potenza del pesante” che trasuda dagli stilemi e dalla grafica di quella (ex) Unione Sovietica di cui molti hanno subito, pur tardivamente, il fascino.
D’altra parte nel secondo dopoguerra abbiamo avuto il Partito Comunista più forte (come rappresentanza e forse anche in assoluto) dei Paesi occidentali e, ancor prima, durante la guerra di resistenza, i “rossi” erano tra gli schieramenti più nutriti. Ma questo discorso ci porterebbe lontano da quello che qui vorrei – per quanto possibile: brevemente – raccontare.
Un racconto per il quale l’altro giorno ho deciso unilateralmente di lasciare tutto (lavoro, famiglia, Lu::Ce edizioni, ASPO Italia) e prendermi il tempo per andare a vedere questa mostra annunciatami da un paio di amici, visitabile fino all’11 febbraio 2024, in una delle sedi dello splendido Palazzo Magnani (gli altrettanto notevoli Chiostri di San Pietro) in una delle gemme dell’Emilia, Reggio.
Dunque: i CCCP – Fedeli alla linea. Nascono come gruppo musicale punk-rock (Wikipedia dice nel 1982, anziché 1984 – ma alla fine poco importa, visto che «la vita umana non dura che un istante», come recita uno dei “manifesti” appesi alla mostra…). Nel 1984 avevo 14 anni e NON ascoltavo i CCCP, che però ho ascoltato un po’ dopo. Oddio: “ascoltato” è una parola grossa, visto che erano sostanzialmente inascoltabili (o almeno: lo erano per me all’epoca e hanno poi continuato a esserlo). Sonorità fatte per scrollare dal torpore, soliloqui/sproloqui borderline del frontman Giovanni Lindo Ferretti, ma forse non capivo o non capivo abbastanza. Perché alla fine, un po’ come per i libri che si leggono, le canzoni e lo stile musicale è “figlio” del suo tempo – “stile” che entra in consonanza con il tuo sentire di quel momento, con quello che provi. Cose belle, sembrano brutte dopo pochi anni e viceversa. Insomma: di nuovo panta rei, tutto scorre. Una canzone è una foto sonora di un “momento” e di un momento all’interno di uno “stile” e noi possiamo trovare interessante quel momento e quello stile (in quel momento o in altri successivi), anche se noi scorriamo sostanzialmente sempre. Sia come sia: le cose si (ri)valutano (anche) a posteriori e questa era una di quelle da rivalutare. La valutazione di un percorso alternativo, dell’affrontare la vita con un altro cipiglio, quello dell’irriverenza, con il rischio di essere condannati all’irrilevanza.
Così non è stato. I CCCP – certo erano altri tempi – qualche comparsata l’hanno fatta anche sulle TV nazionali e, oltre che sulla RAI, anche su Canale 5, con un Ferretti ancora giovane e capelluto, con una cresta che sfidava il cielo… fino a toccare “l’apoteosi” della “celebrità mainstream” con Amanda Lear – il tutto ben documentato nella mostra. Ma così non è stato per la qualità di almeno due delle colonne portanti del gruppo: lo stesso Ferretti e, per la chitarra, Massimo Zamboni. Se il “vino è buono” poi si sente e alla fine il giudizio, spesso severo, di ciò che resta e ciò che semplicemente cade nell’oblio, spetta al tempo.
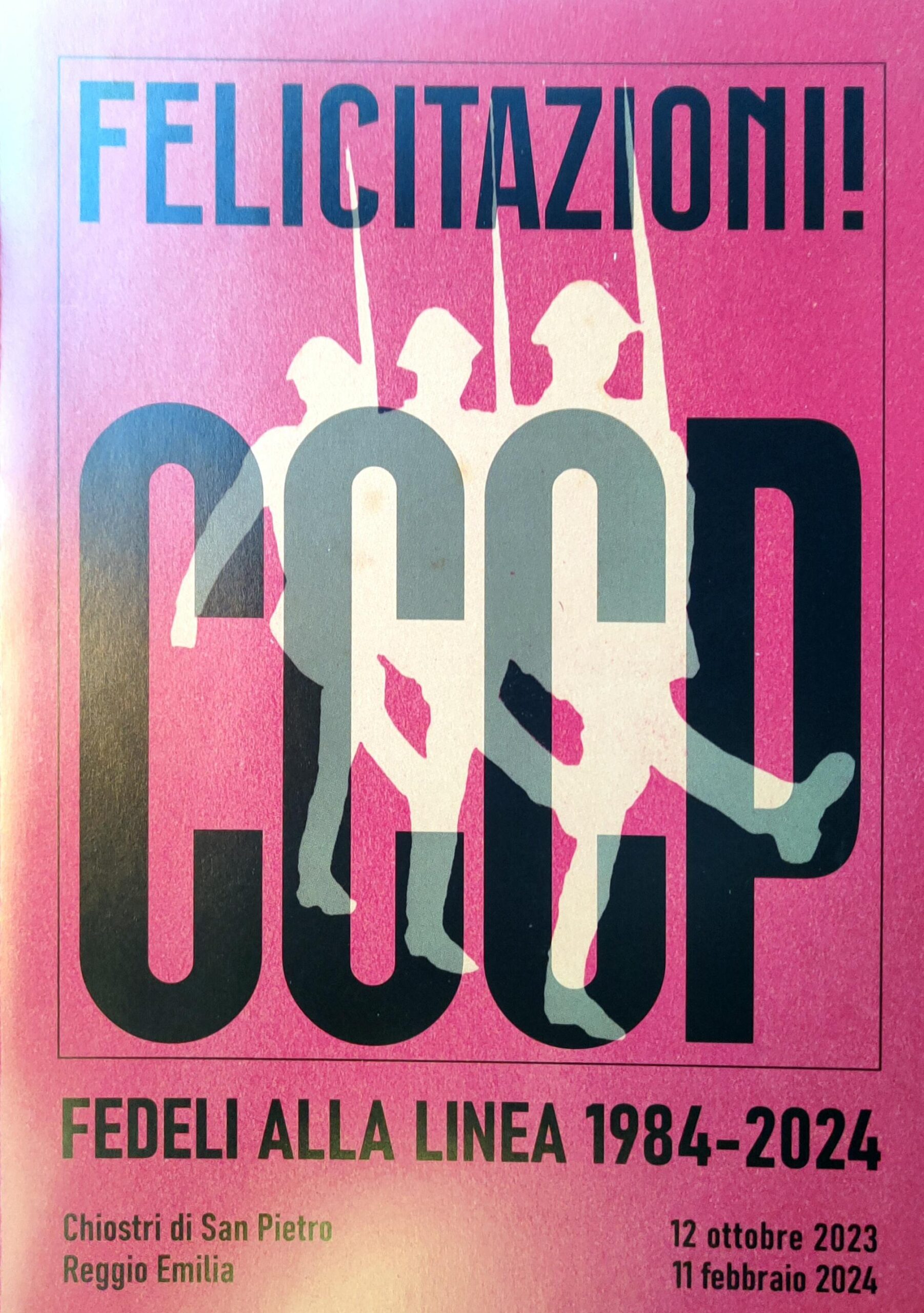
Volantino della mostra
Così il tempo passa e dissoltosi ciò che sembrava indissolubile nei primissimi anni ’90 (l’Unione Sovietica diviene “ex” e dà luogo alla Comunità degli Stati Indipendenti – CSI) i CCCP, che continuano a essere fedeli alla linea, diventano CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. E, per quel poco che mi riguarda (ma io conto per me), “il bruco diventa farfalla”: le sonorità, che pure sempre da quel mondo rock-punk arrivano, si smussano, lasciano spazio al virtuosismo degli strumenti e della voce di Ferretti, che smette i ritmi concitati e sincopati del punk più intransigente in favore di testi e musiche di grandissima poesia (sempre opinione personale). Allora ciò che fino al giorno prima era simbolo di una realtà – o dell’immagine di quella realtà proiettata di qua dalla Cortina di Ferro – con tutto il suo portato di retorica e di “stile sovietico”, diventa, il giorno dopo, poco più che nostalgica paccottiglia. Paccottiglia centellinata negli spazi piuttosto grandi, quelli del Chiostro di San Pietro, con grande parsimonia – chissà, forse certe cimeli con le scritte CCCP adesso potrebbero avere anche un valore. In mezzo al chiostro: un pezzo originale del muro di Berlino, dei cavalli di Frisia e un simbolo, o forse “il” simbolo dell’ex DDR (o Repubblica Democratica Tedesca), di quel “sovietismo” così vicino a (e così lontano da) noi, appena oltre il confine: la Trabant (un esemplare per altro in ottima forma, station wagon…).
C’è poi, sotto traccia, tutta l’evoluzione hegeliana di Ferretti, che si spreca in tesi (il comunismo, la “fedeltà alla linea” come “antidoto” – come dargli torto, in quei tempi? – alla “balena bianca” della DC imperante in un’Italietta con cittadini al di sopra di ogni sospetto, con le logge massoniche, che faticava a uscire dal bozzolo – ma ci è mai veramente uscita? – sempre in bilico, tra “cattolico decoro / a modo e per bene”, moti rivoluzionari e molto molto molto altro), antitesi (il cattolicesimo osservante e piuttosto ortodosso) e una sintesi – che francamente non mi è chiara, ma che si riassume nella giustapposizione tra contenuto (la mostra stessa) e contenitore (i chiostri di San Pietro che, in quanto santo, lascia supporre l’origine ecclesiastica di tutto il complesso…). Il tutto in una ancora più grande, se possibile, contraddizione, che però è del tutto radicata e connaturata al nostro tempo: Reggio Emilia.
Una città bella (ma dell’Emilia Romagna io sono segretamente innamorato, forse perché proprio da quelle parti ho avuto i miei primi amori ragazzini…), in gran spolvero (poi sotto Natale, quale città non lo è?), dove, a giudicare dal tasso di automobili di lusso e dalle gioiellerie, si immagina una grande, se non grandissima, ricchezza (economica), al punto che si fatica a immaginarla “popolare”, sebbene uno dei cartelli, sempre della mostra, la citi come la città più “filosovietica” della già “filosovietica” Emilia. Non mi stupisco in Occidente quanto mi sono stupito in Oriente: l’unica volta in cui passai da Mosca, nella lontana estate del 2005, una gigantesca gigantografia (quindi una sorta di “gigantesco al quadrato”) della Rolex – simbolo per antonomasia del lusso occidentale, tutto sommato abbastanza inutile (stiamo parlando comunque di un orologio, per altro nemmeno tra i più precisi, che alla fine ci dice che ore sono…) – campeggiava sulla Piazza Rossa a dirci, se mai ce ne fosse il bisogno, che il comunismo era finito anche lì da un po’. Insomma: è un po’ la vecchia storia della Volkswagen, letteralmente “l’auto per il popolo”. Magari una volta: adesso, se vuoi comprarti non una Passat, ma anche solo una Golf o una Polo vediamo subito a che fetta di popolo ci stiamo riferendo.
Chiudo: i CCCP sono (stati) certamente importanti, per quel che mi riguarda per l’irriverenza e anche, perché no, una certa goliardia nel prendere per i fondelli il nostro modo di vivere, quello di tutti noi “borghesi” (fatti, finiti o aspiranti tali), con tutte le nostre convenzioni, con i nostri convincimenti, con le nostre, alla fine, “piccole vite”, poco coraggiosi non solo a provarne delle altre – mentre almeno un po’ questi musicisti e altri ancora, come “Dome La Muerte” che ho avuto il piacere di conoscere, questa prova almeno l’hanno fatta – ma anche solo a immaginarle (parlo sempre per me).
Almeno mio padre, che ha fatto l’operaio tutta la vita, ma metà di quella stessa vita l’ha giocata a pallone, quando “era ora” giocò con le maglie che si fecero fare apposta: rosso (che più non posso), falce e martello sul cuore e la scritta CCCP. Una foto li ritrae in formazione (devo cercarla accidenti a me, sono sicuro che è conservarta in qualche cassetto di casa dei miei). Abitavamo a Pinerolo e la scritta erano le iniziali dello sponsor calcistico: Caffè Club Centrale Pinerolo, CCCP. Tra il serio e il faceto almeno ci si provava e mio padre portava dei baffi alla Frank Zappa.
Ma i CCCP per me sono stati importanti proprio perché sono diventati CSI e poi, in una certa misura, quando ancora si sono trasformati in PGR. L’importanza è la misura di quanto ci si riconosce in quei testi e quelle musiche o, ancora, in quanto si è “distanti” nel proprio modo di vivere da tutto ciò. Non mi si fraintenda: non voglio vedere nel gruppo in generale e in Ferretti in particolare un “guru” (la tentazione in molti è forte…), ma senz’altro hanno detto e hanno continuato a dire per molti anni cose interessanti, a proporre testi e visioni della realtà che mi sono sentito, in molti casi, di sottoscrivere.
Chiudo (davvero stavolta) con un esempio: stiamo terminando un 2023 all’insegna di un paio di guerre che hanno affollato le nostre “notizie di cronaca”. Proprio Ultime notizie di cronaca si intitolava un album dei PGR del 2009, quindi ormai quasi un quindicennio fa. In quell’album una canzone, tra le altre, che mette insieme un po’ dei “temi” delle nostre vite e del nostro modo di vivere. Si può ascoltare su YouTube a questo link, (ancora una volta trovo le sonorità molto “azzeccate”…) mentre il testo lo riporto qui di seguito:
Boom economici risorse energetiche
guai finanziari spot pubblicitari
high-tech bio-tech igiene genetica
bolle fondi sovrani
nel sol dell’Avvenire che avviene
nel sol dell’Avvenire che è
l’uomo s’assottiglia dimensione catodica
immagine dislocabile monodimensionale
porno-maniacale reality e virtuale
già consumatore l’uomo si vuole clone
una merce qualsiasi lo era da schiavo
lo sarà da padrone
armate schierate ambo i lati del fronte
così che il fuoco amico è tanto il primo che l’ultimo
tecnologie obsolete congegni scaduti scorie rifiuti
a tessere l’ordito d’un sudario calvario
novantanove guerre nel sol dell’Avvenire novantanove
novantanove e una come nessuna
mai dire mai col senno di poi
la carne s’è fatta vendetta il corpo è la bomba perfetta
pacco esplosivo sigillato in provetta
bomba intelligente sporca asettica
il corpo è la bomba perfetta la carne s’è fatta vendetta